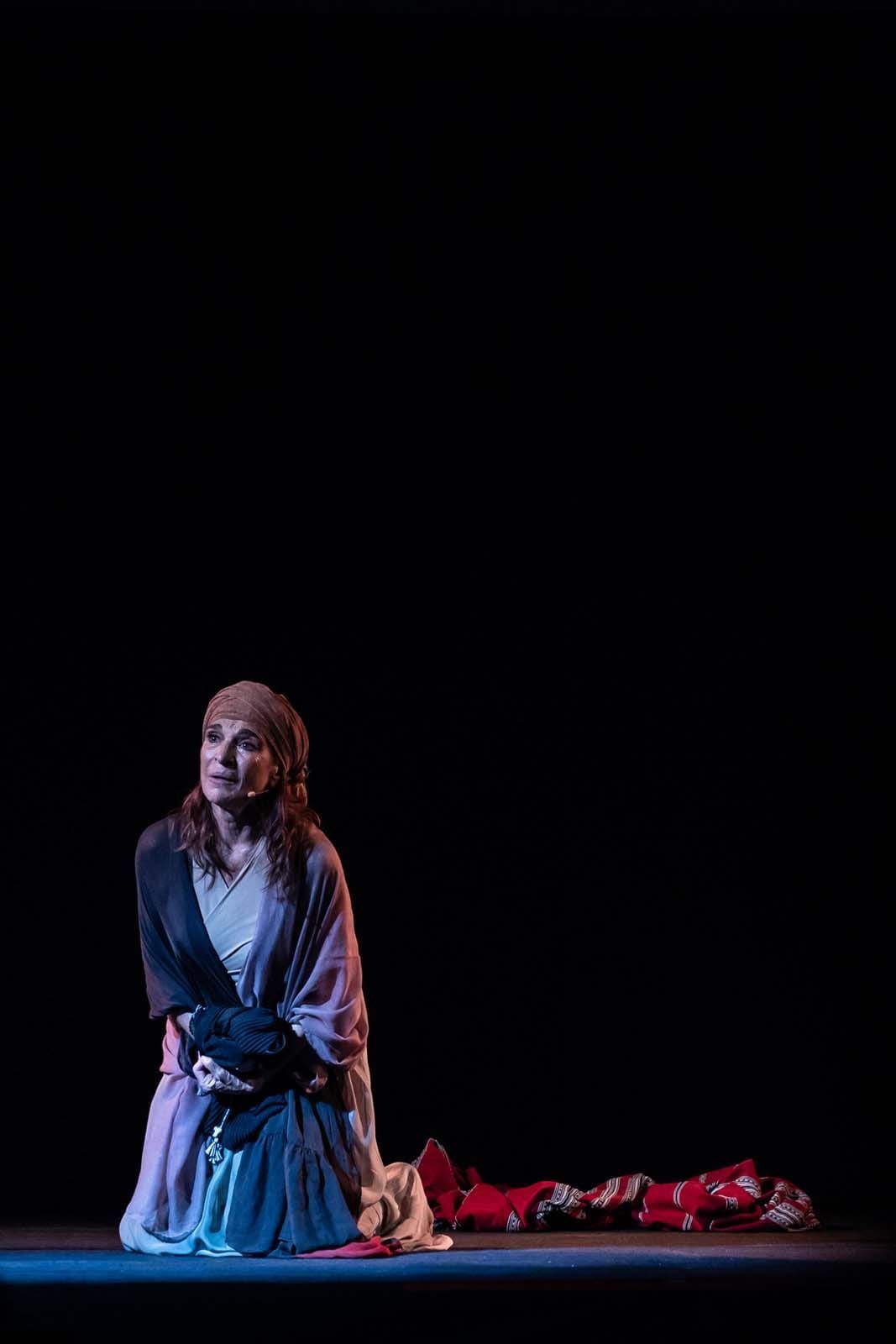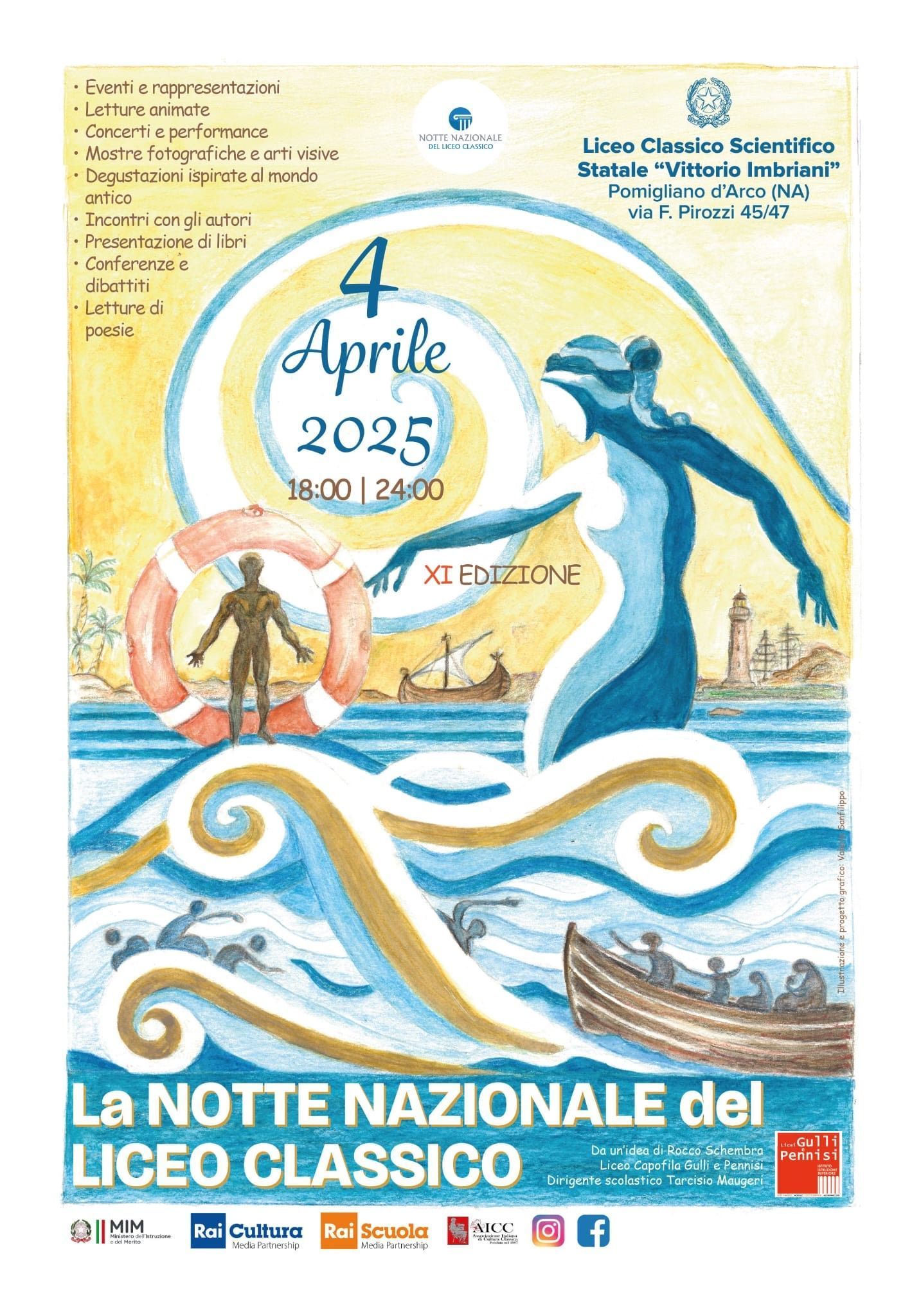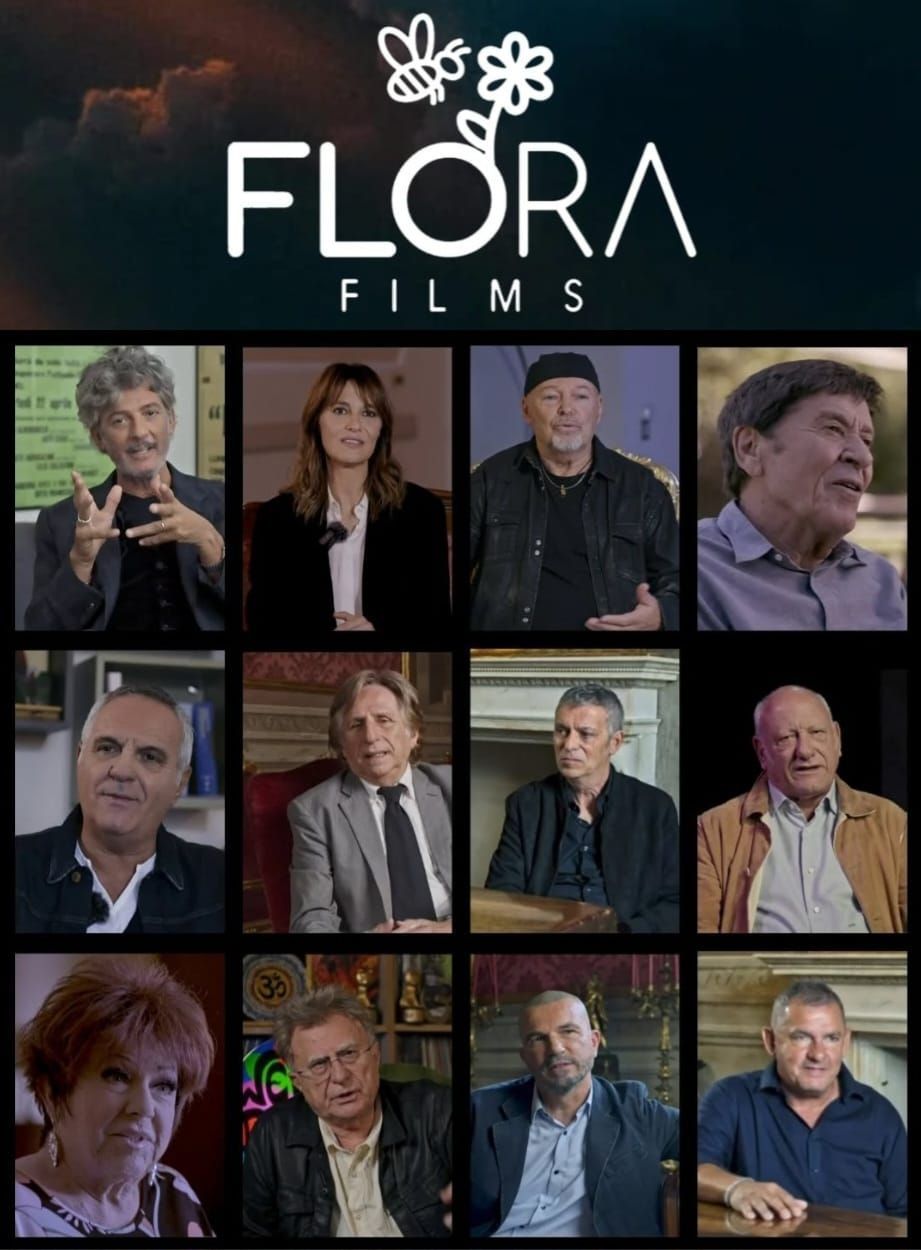Pierluigi Testa (Opinion Maker): "Meloni in Ucraina è grande segnale diplomatico. Suo comportamento in Europa impeccabile"
Pierluigi Testa (Opinion Maker): "Meloni in Ucraina è grande segnale diplomatico. Suo comportamento in Europa impeccabile"

1 - Dott. Testa (economista e opinion maker), “Italia e Francia devono dare una risposta all’immigrazione insieme. Anche andando a negoziare in Africa. Lo spiega all’AGI l’inviato speciale del presidente francese Emmanuel Macron per il Medio Oriente e il Mediterraneo, Gilles Kepel. È la strada giusta?
L’apertura data dall’inviato speciale del presidente francese Emmanuel Macron, Gilles Kepel, rappresenta un importante spartiacque nelle relazioni internazionali e nella reputazione del nostro paese.
Infatti, se da un lato riconosce all’Italia un ruolo attivo e determinante nella delicata questione dei flussi migratori provenienti dall’Africa, dall’altro risponde anche all’esigenza di trovare una soluzione a questo problema che comunque è di competenza nazionale, oltre che europea.
I problemi vanno sì affrontati in Africa, dove c’è la possibilità di limitare flussi in partenza attraverso lo strumento della cooperazione, migliorare l’accoglienza dei profughi, contenere le partenze degli immigrati irregolari, gestire eventualmente i barconi prima che partano, creare hotspot sul territorio. In aggiunta, occorrerebbe finanziare attività di formazione di giovani in loco, se si possono utilizzare fondi appositi.
Qualsiasi problema che arrivi dentro i confini dell’Unione Europea è destinato quasi sicuramente crescere in termini di magnitudine: ad esempio l’integrazione non funziona come dovrebbe non solo in Italia, ma anche e soprattutto nei paesi europei con tradizione di immigrazione (ad es. la Francia); poi c’è la questione del numero dei rimpatri, troppo esiguo rispetto a quello che dovrebbe essere gestito.
In questa interazione, suggerita dai francesi, l’unica attenzione che il nostro governo dovrà prestare è nel negoziare bene il ruolo dei due paesi (Italia e Francia) e l’obiettivo comune con i nostri amici d’oltralpe, in quanto alle aperture in tema di politica estera possono poi seguire richieste dalla nostra controparte su questioni riguardanti rapporti specifici tra i due paesi.
2 - La Meloni, dopo un colloquio con Scholz, va a Kiev il 24 febbraio. Legge tracce di diplomazia?
L’Italia ha sempre fatto la sua parte nelle relazioni internazionali. Si tratta, pertanto, di un forte segnale diplomatico. Bisognava marcare continuità con quanto già fatto dal premier britannico Boris Johnson, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal nostro precedente Presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e farlo in un momento molto delicato; ovvero un momento in cui le forze armate russe sembra si stiano riorganizzando per sferrare un nuovo attacco su vasta scala in terra ucraina.
Questa visita rappresenta anche una decisa vocazione alla politica estera della nostra Signora Premier e una postura più marcata del nostro Stato, ed è stata decisa con coerenza rispetto alle nostre alleanze storiche. Ha, poi, ancor più valore perché presa da un Governo politico, rappresentando de facto anche una ripresa del nostro ruolo nelle relazioni internazionali.
3 - I partiti si dividono sul DDL Autonomia. Ma a chi giova?
La spinta verso la c.d. “autonomia differenziata” - di cui possono fruire le Regioni interessate in base all'articolo 116 della Costituzione, e che si applica a 23 materie a legislazione concorrente (istruzione, rapporti internazionali e con l'Unione europea, commercio con l'estero, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica et cetera), è stata impressa con i referendum del 2017 in Lombardia e Veneto che hanno dato esito positivo all’autonomia differenziata allo Stato.
In generale, pertanto, se da un lato abbiamo la lega che si è intestata questa battaglia, dall’altro non vanno trascurate le pesanti ripercussioni che questa autonomia ha non solo nei rapporti tra Stato e Regioni ma soprattutto nei rapporti tra Regioni – alcune che possono beneficiare di una maggiore capacità gestionale e altre che invece dovranno rincorrere.
La divisione tra i partiti – anche all’interno della coalizione di governo – su questo tema va inquadrata sotto la lente dei bacini elettorali di riferimento, oltre che sul diverso ruolo che alcuni partiti e leader politici attribuiscono allo Stato e alle regioni.
Questa dialettica, oltre a rallentare il processo legislativo, potrebbe portare a un ripensamento dello schema iniziale, quindi potrebbe giovare proprio quelle regioni che hanno un gap, un ritardo rispetto a quelle “best in class” e contribuire a delineare un quadro più equilibrato nei rapporti Stato-Regioni.
In ogni caso, che ci si divida oppure no, la vera questione dirimente è che l’autonomia differenziata è vuota di due aspetti: il primo attiene a cosa inserire dentro i c.d. “Livelli essenziali di prestazione” (LEP), mentre il secondo si riferisce a come determinare i costi standard di servizio che costituiranno un modello di riferimento vincolante per le regioni.
Non si è detto ancora nulla, nel dettaglio, su questi due aspetti, che sono il nodo della questione.

4 - Le grandi multinazionali del Tech chiudono male il quarto trimestre? Da cosa verranno soppiantati?
Non vedo ancora minacce per le big corporation americane in ambito tecnologico. Nel momento in cui scrivo, la capitalizzazione di borsa di Google è di 1.321 miliardi di dollari, quella di Amazon è di 1.047 miliardi di dollari, mentre la borsa italiana registra una market cap di 598 miliardi di euro.
Pertanto, per queste corporation non ci sono problemi provenienti dall’esterno. L’unica dinamica rilevante è capire nei prossimi anni chi ingloberà chi, o chi crescerà ai danni di chi tra queste aziende “peer”.
A questo contribuirà il tasso di adozione da parte dei consumatori delle nuove piattaforme (ad esempio il metaverso), ma è troppo presto per parlare di trend favorevoli a creare nuovi operatori “incumbent”.
5 - Si parla di Umanesimo 4.0 e Intelligenza artificiale. L’uomo che ruolo avrà?
La tecnologia è sempre più pervasiva nella nostra vita e arriva a modificare anche il nostro lavoro. Sicuramente le macchine da sempre o da molto tempo per lo meno influenzano la vita produttiva e sociale delle persone. Ma ultimamente chiediamo sempre di più alla tecnologia. Vogliamo che le macchine non solo lavorino per noi, ma ragionino per noi interpretino per noi si adattino per noi.
Questo avviene grazie all’Intelligenza Artificiale, che ci spinge a conferire quasi un’anima alle macchine.
La trasformazione in corso verso il digitale richiede, tuttavia, un nuovo approccio al lavoro e una nuova forma mentis.
Le macchine possono aiutarci a svolgere compiti più nobili intellettuali e al contempo limitare la nostra esposizione a lavori rischiosi o addirittura pericolosi, contribuire a prevenire azioni sbagliate e a migliorare la qualità del nostro lavoro.
Cosa deve fare l’uomo: l’uomo deve costruire, istruire e gestire la macchina, quindi deve essere in grado di intervenire in caso di malfunzionamento o di anomalia.
A questo concorre l’attività di impostazione degli algoritmi che forgiano il comportamento della macchina, ma che per questa via conduce anche a una questione etica: cosa è giusto che la macchina faccia?
Per rispondere a questa domanda sono richieste all’uomo non solo competenze esistenti ma anche competenze nuove, trasversali che nascano dall’interazione tra persone con diversa specializzazione ed estrazione culturale. Occorrono think tank che possano discutere in modo olistico sulle implicazioni dell’utilizzo delle macchine nella nostra vita quotidiana.
6 - In Francia continua il braccio di ferro sulle pensioni. I sindacati fanno salire ulteriormente la pressione con altre due giornate di protesta in arrivo il 7 e l'11 febbraio ma il governo resta inflessibile. È la fase gilet gialli 2.0?
La riforma delle pensioni è avversata in modo trasversale da destra, centro e sinistra e trova opposizione in tutte le fasce sociali per diversi motivi.
Salari impoveriti, esigenze fiscali, inflazione fuori controllo nell’ultimo anno.
Ritengo, pertanto, che si tratti più di un moto di piazza popolare, che raccoglie istanze diverse, che di “gilets jaunes 2.0” di cui non parlerei in questa circostanza.
La gestione della riforma della pensione attiene a scelta politiche.
L’impoverimento della massa della manodopera va avanti da almeno vent’anni, e si riferisce anche a scelte di fondo sul mondo del lavoro legate alla globalizzazione, che ha portato alla ribalta il confronto con costi del lavoro per unità di prodotto su base mondiale e non nazionale.

7 - Dott. Testa (economista e opinion maker), con la pandemia i bambini hanno perso un terzo dell'apprendimento annuali. Sono i risultati di uno studio condotto in 15 paesi ad alto e medio reddito. Che riflessi avrà questo?
Non ritengo che ci sia un riflesso di medio-lungo termine nell’apprendimento di un bambino dovuto alla pandemia.
Gli stimoli cognitivi che ricevono oggi i minorenni sono di gran lunga più elevati rispetto alle precedenti generazioni. Pertanto, c’è più un problema di “sintesi” delle informazioni e della conoscenza oggi disponibile, che di carenza.
Fatto salvo l’aspetto culturale e nozionistico, una voragine non ancora nota si potrebbe aprire nei prossimi anni sull’aspetto psicologico, in quanto non conosciamo quali siano le ricadute di medio-lungo termine sul comportamento dei bambini derivanti dalla gestione della pandemia che ha portato con sé anche numerosi messaggi di paura - che gli adulti probabilmente non sono riusciti a celare ai propri figli. Su questo si potrebbe aprire un lungo dibattito.
8 - È opportuna la presenza dì Zelensky a Sanremo?
Credo che la presenza o meno di un presidente di un paese amico in guerra all’interno del Festival musicale della canzone italiana, in un momento così delicato, sia proprio da valutare in termini di opportunità - e questo a maggior ragione se si tratta di un canale televisivo pubblico.
Tra i pro sicuramente potremmo dire che tale evenienza risponde anche e soprattutto all’istanza di “realpolitik”, ovvero di sensibilizzare in modo diretto l’opinione pubblica.
Si tratterebbe di un’operazione di c.d. “soft power” verso l’opinione pubblica che va a rinforzare il ruolo e la reputazione del nostro paese in ambito atlantico.
Per dirla in altro modo, l’Italia non si tira indietro rispetto alle decisioni prese in ambito europeo e atlantico e lo fa fino in fondo.
Dall’altro lato occorre anche considerare che da numerosi sondaggi tale presenza non sia gradita alla maggioranza degli italiani.
In sintesi, chi decide dovrà valutare se dare maggior peso al nostro paese nei consessi internazionali o ascoltare l’opinione pubblica interna.
Purtroppo, l’attività di governo richiede spesso di decidere tra dicotomie.
9 - Che idea si è fatto dei palloni-spia nei cieli Usa?
A prescindere dai palloni spia nei cieli degli Stati Uniti d’America, possiamo affermare con una certa aderenza alla realtà che se tale attività dovesse rispondere ad un controllo del suolo americano, non sarebbe nuova in sé ma si aggiungerebbe a quella che già viene fatta attraverso i satelliti.
Sono decenni che i paesi più importanti al mondo utilizzano ogni sorta di tecnologia utile per conoscere cosa fanno i loro vicini.
Quello dei palloni sarebbe un ulteriore strumento che si aggiunge alla lunga lista esistente.
10 - I Russi saranno ammessi ai giochi olimpici solo se rinunciano alla bandiera nazionale. Che ne pensa?
Innanzitutto, le Olimpiadi sono dei giochi che stabiliscono chi è l’atleta o una squadra più forte in una disciplina sportiva, in un appuntamento mondiale che ha una cadenza quadriennale.
Ciò posto ci sono state prima di oggi numerose sollecitazioni alle Olimpiadi provenienti dalla situazione dello scacchiere internazionale, a partire dall’edizione del 1956 in cui alcuni paesi europei boicottarono la propria partecipazione a causa dell’occupazione russa in Ungheria e la Cina non partecipò in protesta verso il permesso dato a Taiwan di partecipare ai Giochi come Paese a sé stante. Di più recente memoria le Olimpiadi di Mosca del 1980, boicottate dagli Stati Uniti d’America in protesta per l'invasione sovietica dell'Afghanistan e quelle successive a Los Angeles (1984) boicottate questa volta dalla Russia in risposta al boicottaggio dell’edizione precedente.
Tuttavia, in merito al punto, l'idea del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sarebbe quella di permettere la partecipazione di sportivi russi e bielorussi ai Giochi di Parigi 2024 in quanto "atleti neutrali", senza bandiere o inni nazionali, così come anche auspicato dagli Stati Uniti d’America, attraverso la portavoce della Casa Bianca Katerine Jean-Pierre. Di diverso parere è l’Ucraina che boicotterebbe l’evento in caso di partecipazione di atleti russi e bielorussi anche senza bandiere.
Pertanto, le resistenze da superare sono due: la prima riguarda l’appurare il fatto che gli atleti russi vogliano e soprattutto possano partecipare ai giochi olimpici secondo la formula prospettata – e resta da capire quale sarebbe la posizione del Cremlino in proposito – la seconda invece riguarda la posizione ucraina.
Personalmente ritengo che le Olimpiadi, anche per come si collocano temporalmente (2024), possano essere una buona occasione magari per vedere la questione del conflitto già risolta e dare in tal senso un segnale forte a favore del processo di pace.
In ogni caso lo sport dovrebbe sempre resistere e vincere contro le dinamiche politiche internazionali, ma il percorso verso i giochi – come ci insegna la storia – non è mai privo di ostacoli.
Share
Tutti gli articoli