La strana catena di montaggio tra magistrati e giornalisti nel passaggio di informazioni
La strana catena di montaggio tra magistrati e giornalisti nel passaggio di informazioni

Non è più rinviabile una verifica con interventi correttivi sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente) sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali.
Siffatte "attività di disinformazione" includono altresì la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzino i dati degli utenti.
Secondo la definizione adottata dalla Commissione europea nella Comunicazione congiunta "Relazione sull'attuazione del piano di azione contro la disinformazione (JOIN/2019/12 final)", l'attività di disinformazione è "un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte". Secondo la Commissione europea, "obiettivo della disinformazione è distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti, al fine di disorientare i cittadini minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi
politici consolidati".
Si è sostenuto in dottrina che l'attività di disinformazione si colleghi al concetto
proprio del tempo post-moderno di "post-verità" ossia di una verità costruita non su basi oggettive ma in conseguenza di "una relazione di complicità, di emozione e di reciprocità, tra chi, di volta in volta, parla o ascolta. Anche invertendo i ruoli". "Non si tratta dunque di una mera bugia ma piuttosto della verità desiderata da chi la professa e da chi la accoglie" (A. Nicita).
Uno degli strumenti più tipici della diffusione della disinformazione è rappresentato dall'utilizzo di identità digitali false, che ha formato già da tempo oggetto di attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali si pronunciò per la prima volta nei confronti di Facebook nel 2016 [doc. web n. 4833448], imponendo di bloccare i falsi profili (i cosiddetti fake) e di assicurare più trasparenza e controllo agli utenti, affermando innanzitutto la propria competenza a intervenire a tutela degli utenti italiani.
Una forma più sottile di disinformazione è rappresentata dalla segnalazione automatica agli utenti di contenuti in forma personalizzata, avvalendosi dei dati personali degli stessi utenti, sia con finalità commerciali sia con finalità informative. In tal caso, le informazioni possono non essere totalmente false ma potrebbero essere tendenziose essendo, in qualche modo, tarate, ad esempio, sulla precedente attività della persona (espressa ad esempio attraverso "like" a pagine con particolari tipologie di contenuti) o semplicemente sulla navigazione di ciascun utente.
Spesso i due fenomeni (la creazione di profili falsi e la produzione di contenuti falsi o tendenziosi) sono connessi.
Con riferimento alla pubblicazione di informazioni sui media tradizionali, si ricorda che l'articolo 2 della legge n. 69 del 1963, recante ordinamento della professione di giornalista, stabilisce che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata, però, oltre che dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, dall'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Le notizie che risultino inesatte devono essere rettificate e gli eventuali errori devono essere riparati.
Altre disposizioni riguardano l'etica della professione e attengono al rapporto tra il giornalista e la categoria di appartenenza (ad esempio, il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori, il mantenimento del decoro e della dignità professionali, il rispetto della propria reputazione). La loro violazione comporta una responsabilità di tipo disciplinare, che viene accertata da appositi organi (Consigli regionali e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti) e prevede la comminazione di sanzioni disciplinari (di cui agli articoli 51-55 della medesima legge n. 69 del 1963).
Esse sono l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di due mesi a un massimo di un anno, e la radiazione dall'albo.
A sua volta, l'articolo 2 del Testo unico dei doveri del giornalista (approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine il 27 gennaio 2016, e nato dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di facilitare l'applicazione delle norme la cui inosservanza possa determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine) pone, tra i fondamenti deontologici, il principio secondo cui il giornalista è tenuto a difendere il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona, e per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.
Con specifico riguardo ai doveri in tema di rispetto delle fonti e di rettifica, l'art. 9 stabilisce, tra l'altro, che il giornalista: controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità; rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre (tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network); non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento. Si rende necessaria però una riflessione circa la strumentazione giuridica esistente in materia di contrasto delle attività di disinformazione, a fini di sua eventuale rivisitazione.
Figura tra questi la verifica dello stato di attuazione della normativa vigente e delle attività e delle procedure e delle risorse (da valutare se congrue o meno).
Con riferimento al settore privato in particolare bisogna verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente) per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme.
La verifica si estende alle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa. Da verificare inoltre la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti (media e fornitori di servizi delle reti e piattaforme), nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione dalle proprie piattaforme, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi.
Rimangono ferme le prerogative e le competenze dell'Ordine dei giornalisti.
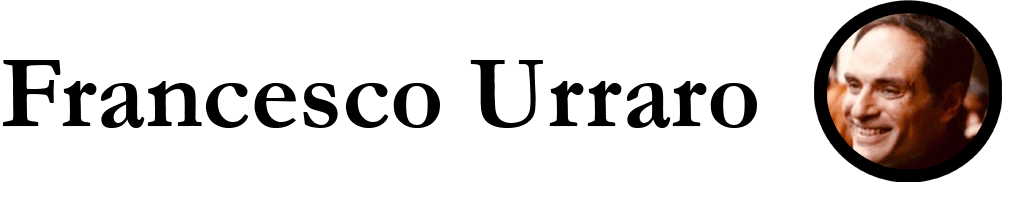
Share
Tutti gli articoli












