Perchè diciamo no alla cannabis
Perchè diciamo no alla cannabis
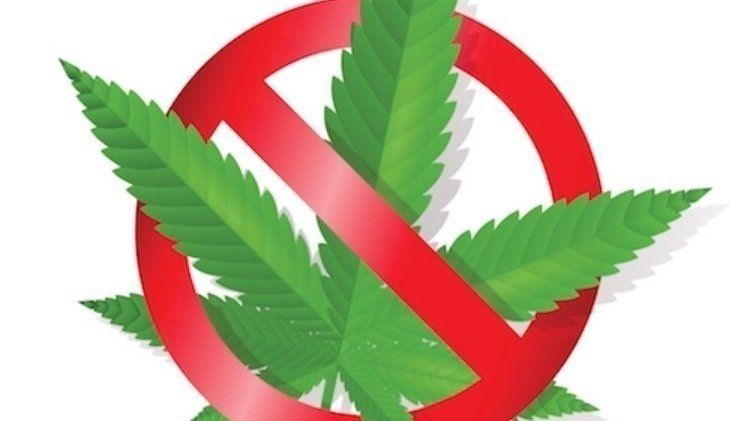
La convinzione che la legalizzazione finalizzata a contenere il fenomeno della diffusione delle droghe e delle attività criminali correlate sia una idea non condivisibile nasce da una serie di elementi e fatti che derivano sia dalle evidenze scientifiche che dalle valutazioni empiriche oltre che di strategia e di politica sanitaria e sociale.
Il problema viene quindi affrontato da più punti di vista e approfondito anche e soprattutto alla luce delle dichiarazioni prima riportate sui principi base che ispirano la politica e la strategia italiana sulla lotta alla droga. È fondamentale infatti focalizzarsi in via prioritaria sulle azioni e sugli interventi che si ritiene indispensabile promuovere all’interno di una politica ben bilanciata e soprattutto permanente, di riduzione della domanda (mediante articolate azioni di prevenzione, cura e recupero oltre che di disapprovazione sociale) e di contrasto dell’offerta (mediante azioni permanenti e sistematiche di lotta alla produzione clandestina, al traffico e alla spaccio).
Il confronto pertanto non può essere semplicisticamente tra “proibizionismo e antiproibizionismo” con un antagonismo sterile quanto infruttuoso, ma va riportato in un’ ottica sistemica molto più ampia dove la legislazione (pro legalizzazione o sanzionatoria dell’uso) è solo una (e probabilmente non la più importante) delle componenti in grado di influenzare l’andamento del fenomeno nel suo complesso. Molto più rilevanti infatti risultano le azioni correlate alla legislazione e cioè gli interventi e l’organizzazione generale costruibile e sostenibile che dovrebbero stare attorno a queste due scelte diametralmente opposte, valutando nel complesso quindi anche il loro costo, la loro sostenibilità reale, la loro accettabilità sociale, l’organizzazione sanitaria e di controllo legale necessarie per mantenere nel tempo tali scelte, la reale efficacia nel medio lungo termine sui consumi e una attenta valutazione su tutto ciò che comporta il sostenere scelte ad alto impatto sociale e sanitario di questo tipo, con un’ ottica che non può essere di breve termine ma necessariamente di lungo termine.
Nel valutare gli elementi che non rendono né possibile né opportuna la legalizzazione delle sostanze stupefacenti (e cioè la legittimazione da parte dello Stato del loro consumo individuale a scopo voluttuario e non medico), vanno ricordati anche alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” In base a questo articolo lo Stato non può pensare di rendere più disponibili sostanze sicuramente tossiche, quali le droghe, in grado di compromettere la salute dei cittadini in quanto si creerebbe un’evidente contraddizione con un principio cardine della nostra costituzione già messo a dura prova con l’alcol ed il tabacco.
Per quanto riguarda poi la legalizzazione e le conseguenze relative all’aumento della disponibilità e del consumo delle droghe va ricordato il conflitto che questo creerebbe, oltre che con l’articolo 32, anche con l’articolo 3 comma 2: “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” L’uso di sostanze infatti è in grado di minare fortemente lo sviluppo della persona, soprattutto dei giovani e compromettere di fatto la possibilità di esercitare un’ effettiva partecipazione alla vita sociale del Paese. Pertanto, sulla base di questi fondamentali principi, si ritiene che lo Stato debba necessariamente mettere in atto tutte le misure di tutela e di promozione della salute di cui sicuramente la legalizzazione delle sostanze stupefacenti, permettendone così un più largo consumo, non fa parte.
La legalizzazione delle sostanze stupefacenti porterebbe ad un più facilitato accesso a tutte le droghe, soprattutto da parte delle giovani generazioni, accompagnato dallo sviluppo e dal mantenimento della percezione che l'uso di tali sostanze è comunque socialmente tollerato, sia dalla comunità, sia dallo Stato. Ciò provocherebbe, quindi, una riduzione dei fattori di "disapprovazione sociale" e “percezione del rischio” derivante dall’uso, così importanti ed in grado di condizionare positivamente il non uso di sostanze da parte dei giovani.
La legalizzazione delle sostanze stupefacenti da parte dello Stato, e quindi il sancire la loro disponibilità in un mercato commerciale legale, oltre che far aumentare il loro consumo creerebbe un altro effetto negativo di “memoria socio-culturale” molto pericoloso che si andrebbe a radicare per lungo tempo nei rituali sociali e nelle credenze, tipiche soprattutto delle fasce giovanili.
Queste sostanze, se legittimate, verrebbero infatti considerate e percepite di fatto come elementi socialmente accettati, in quanto riconosciuti dallo Stato come utilizzabili senza particolari problemi e il comportamento di assunzione verrebbe considerato, soprattutto dai più giovani, “normale” e (ancor più preoccupante) “normalizzante”, legittimato e tutt’altro che a rischio per la propria salute. Più preoccupante ancora sarebbe poi la legittimazione e “normalizzazione” dei comportamenti conseguenti all’assunzione e delle modalità relazionali sotto l’effetto di sostanze, che nel tempo verrebbero consolidati e accettati come stereotipi comportamentali e socio-culturali tranquillamente utilizzabili nelle relazioni interpersonali e non più percepiti invece come criticità.
Gli Stati negli USA che negli anni Settanta avevano attuato politiche di depenalizzazione per possesso di marijuana registrarono un incremento elevato dell’uso della sostanza tra gli adolescenti. In Alaska, ad esempio, nel 1975 una sentenza della Corte Suprema legittimò la marijuana ad uso personale. Nel 1988, un’indagine della University of Alaska rivelò che l’uso di marijuana tra i giovani (12-17 anni) era il doppio rispetto alla media nazionale. La proposta della legalizzazione delle droghe per risolvere, come soluzione radicale ed immediata, il problema soprattutto legato ai grandi guadagni delle organizzazioni criminali, derivanti dalla vendita delle droghe, ha condotto ad ampio dibattito ma la realtà complessa e articolata di questo fenomeno, merita una riflessione ed un insieme di soluzioni coordinate tutt'altro che semplicistiche e di grande responsabilità da parte delle Amministrazioni centrali e regionali competenti.
Tuttavia, prima ancora dell’ottica politica è necessario partire da un principio base di tipo etico e molto realista perché deve essere chiaro che non è il così detto “proibizionismo”, cioè rendere illegale e amministrativamente sanzionabile il consumo di droghe, a dar soldi al crimine organizzato ma chi compra e consuma droga. Quindi, una delle azioni più importanti da fare è rendere consapevoli i consumatori di sostanze e la società in generale che l’acquisto di droga è un comportamento di complicità biasimabile e totalmente da evitare.
Spesso infatti si leggono tesi che accusano chi non vuole legalizzare e liberalizzare il consumo di droghe, di sostenere e promuovere i guadagni delle organizzazioni criminali senza però condannare contestualmente l’uso di droghe ma anzi , soprattutto per la cannabis, portando una serie di argomentazioni che ne giustificano l’uso agevolato e la supposta non pericolosità.
È necessario contestare questo sillogismo tra l’esistenza di una legislazione di tutela e l’agevolare i proventi della mafia, in quanto utilizzato strumentalmente solo per giustificare la legalizzazione delle droghe e farne aumentare la disponibilità e l’accessibilità, nonché l’impunibilità dell’uso voluttario. Pertanto va considerato e sempre ben comunicato un messaggio molto semplice ma altrettanto vero e cioè che queste organizzazioni sono concretamente ed ampiamente supportate esclusivamente da tutte quelle persone che acquistano droga dagli spacciatori, fornendo loro direttamente quel denaro che alimenta proprio le organizzazioni criminali.
I giovani soprattutto devono essere resi fortemente consapevoli che ogni singola dose acquistata e consumata, oltre a danneggiali, finanzia la criminalità e il terrorismo.
Soprattutto i giovani, quindi, devono essere resi consapevoli che il denaro che viene messo nelle mani ad uno spacciatore è esclusivamente sotto la responsabilità di chi glielo dà. Non c'è nessuna giustificazione né morale, né sociale, né legislativa che può assolvere o giustificare tale gesto che ricade unicamente nell’ambito della responsabilità individuale
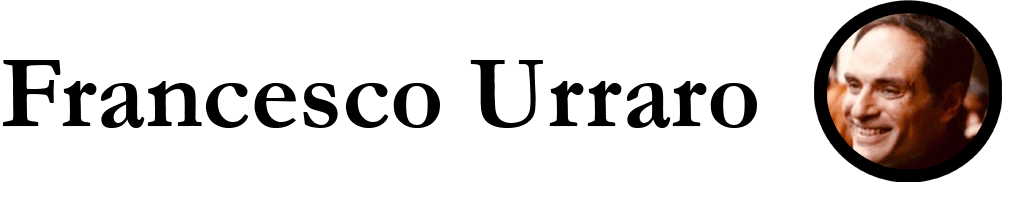
Share
Tutti gli articoli












