Kazimir Malevic, l’inazione come veritá effettiva dell’umanitá
Nato a Kiev, in Ucraina, nel 1878, la sua era una famiglia polacca. Nel 1904 si trasferisce in Russia, dove sviluppa il suo interesse artistico, divenendo uno dei principali protagonisti della scena del primo novecento: pittore, urbanista, pioniere dell’avanguardia.
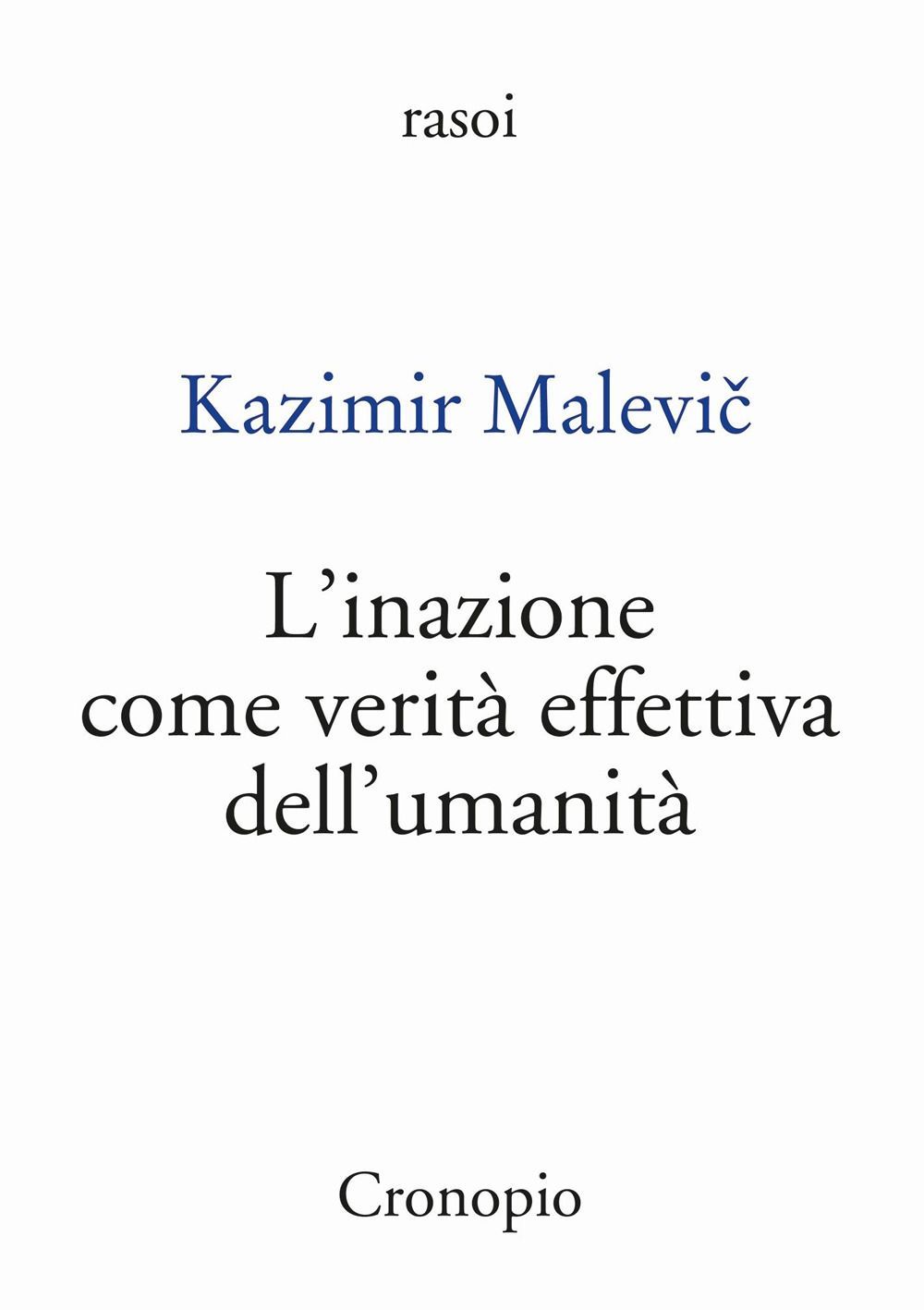
Viene difficile, oggi, calarsi in quella che poteva essere la realtá di un centinaio di anni fa o poco più. Un tempo in cui viaggiare e conoscere doveva essere assai meno agevole che oggi, considerando che noi, grazie alla tecnologia, disponiamo di assai più mezzi. Eppure, per quanto paradossale possa sembrare, l’opera di Kazimir Malevic sembrerebbe dimostrare l’esatto contrario.
Nato a Kiev, in Ucraina, nel 1878, la sua era una famiglia polacca. Nel 1904 si trasferisce in Russia, dove sviluppa il suo interesse artistico, divenendo uno dei principali protagonisti della scena del primo novecento: pittore, urbanista, pioniere dell’avanguardia.
Ce lo ripropone Cronopio, casa editrice napoletana, pubblicando la tradizione di un suo breve scritto del 1921, da titolo L’inazione come veritá effettiva dell’umanitá. Un pamphlet filosofico, dallo stile discorsivo, che esamina uno degli aspetti più pregnanti, e ingombranti, della vita umana: il lavoro e il suo reciproco, cioè l’inattivitá.
Malevic ci rivela un bel paradosso partendo, guarda un po', proprio da riferimenti religiosi. “Il lavoro dovrebbe essere maledetto, come raccontano le leggende sul paradiso, e l’inazione dovrebbe essere ciò cui l’uomo dovrebbe aspirare. Ma nella vita reale è accaduto il contrario. Come sia accaduto, è quello che vorrei spiegare”.
La pigrizia e l’ozio sono comunemente ritenuti la causa di tutti i vizi umani. Un vero nemico da cui guardarsi, perché indurrebbero una disastrosa decadenza. D’altro canto, una societá dove tutti lavorano, dove non c’è uno solo inattivo, sarebbe ritenuta sana e virtuosa: chi non lavora non mangia (secondo Adriano Celentano, non fa anche qualcos’altro). Cosi’, il lavoro assicura benessere, alla comunitá come al singolo. E i sistemi economici e produttivi, prendendosi cura del singolo su vasta scala, finiscono per rafforzare l’umanitá attraverso la sua capacitá di produrre. In questo senso, la preoccupazione di un sistema socialista è esattamene la stessa di uno capitalista. Ma alla fine, la veritá che si nasconde dietro la piena realizzazione di entrambi i sistemi è la medesima tendenza finale all’inazione.
Perché chi accumula, in forma collettiva e socializzata esattamente come chi lo fa in forma individualistica, alla fine vuole arrivare a godersi proprio l’inattivitá. Insomma, si lavora tanto, si produce tanto, per prima o poi fermarsi e darsi all’ozio. Sennò che senso avrebbe tutto ciò?
Eppure, il solo nome dell’inazione, sinonimo di ozio, viene marchiato d’infamia.
A Malevic questo non sta bene. “Che si legga finalmente (…) che l’inazione è il principio di ogni lavoro, che senza di essa non ci sarebbe lavoro”. L’inazione spaventa singoli e popoli, dando cosi’ origine al lavoro, che attraverso la sua piena affermazione e diffusione condurrá infine ad un nuovo paradiso. Fatto di inazione. “Voglio essere io, con piccolo scritto, a levare lo stigma della vergogna dalla sua fronte e a farne non la madre dei vizi, ma la madre della perfezione”, conclude Malevic. Un punto di vista davvero originale.
Tra il 1922 e il 1927 Malevic si dedica a teorizzare la non-oggettivitá, in uno sforzo creativo che prende il nome di suprematismo e vede la propria forza nel collettivismo. Centro di gravitá di questa corrente artistica è in Russia, tra San Pietroburgo e Mosca, ma contemporaneamente trova terreno fertile per allignare a Varsavia e a Berlino, espandendosi poi in tutta Europa. Ciò in un’epoca storica che potrebbe sembrarci più problematica della nostra attuale, ma che in effetti, pur senza i mezzi tecnologici che oggi abbiamo, forse vedeva le idee girare con meno difficoltá.
di Francesco Cristiani
Share
Tutti gli articoli












