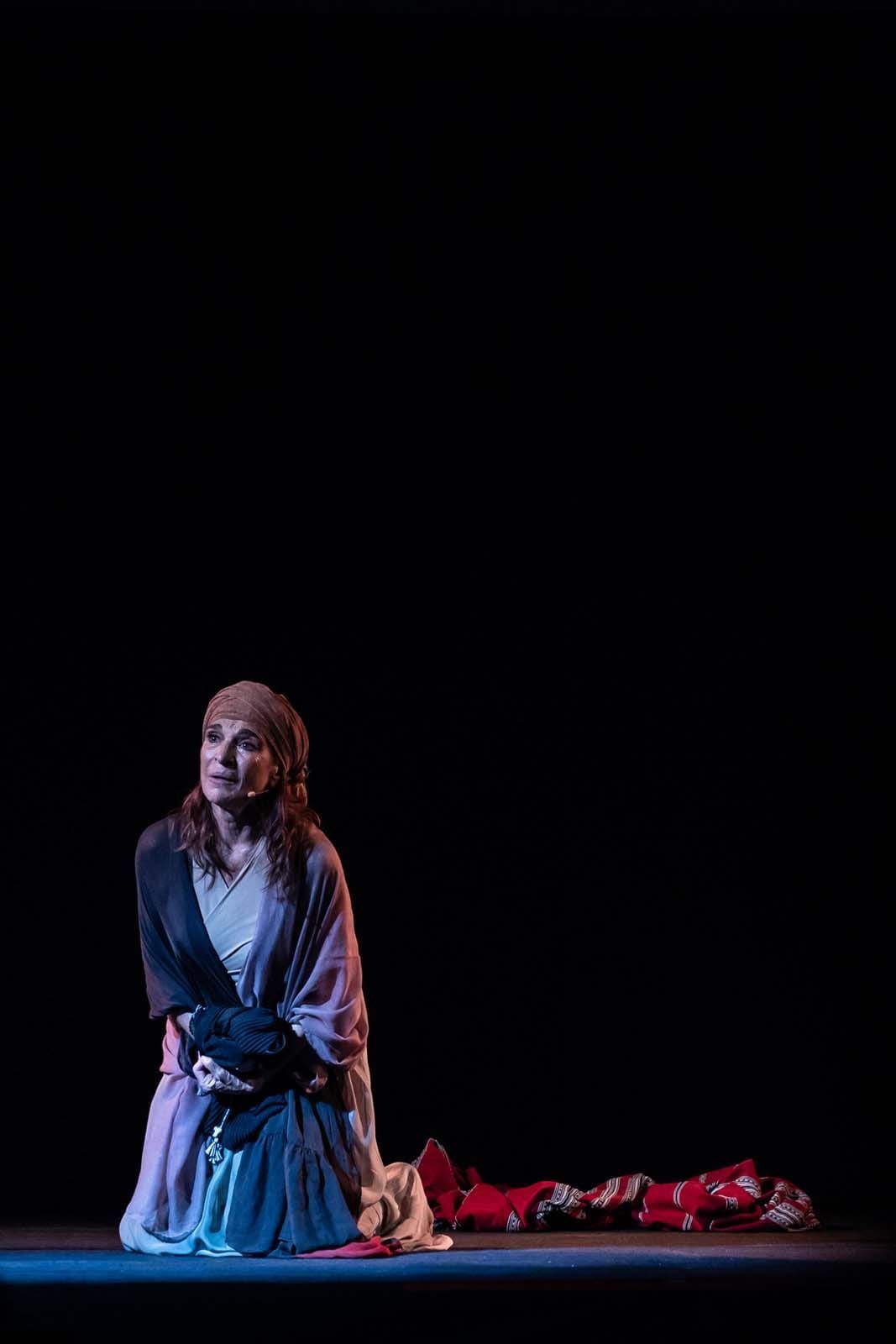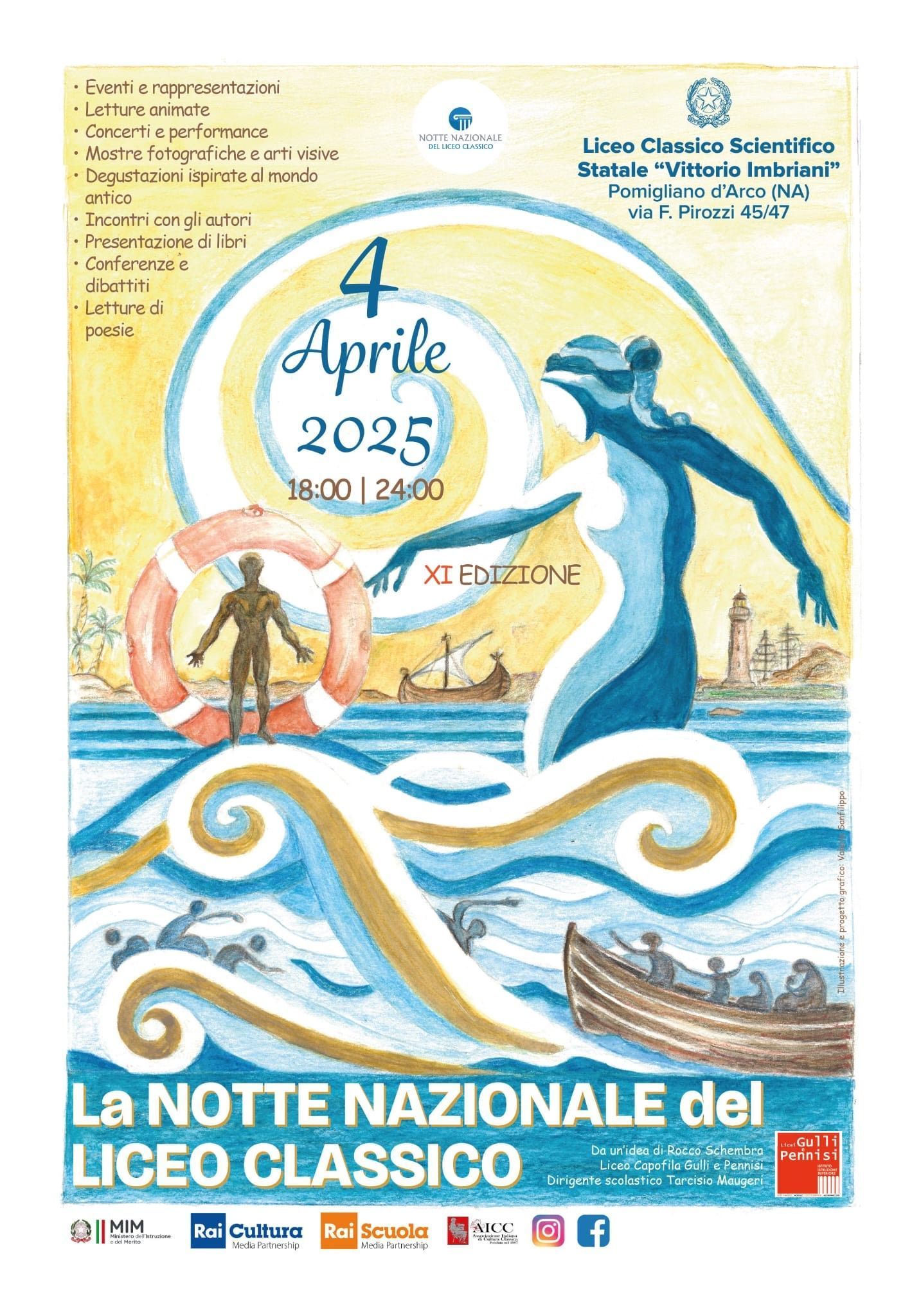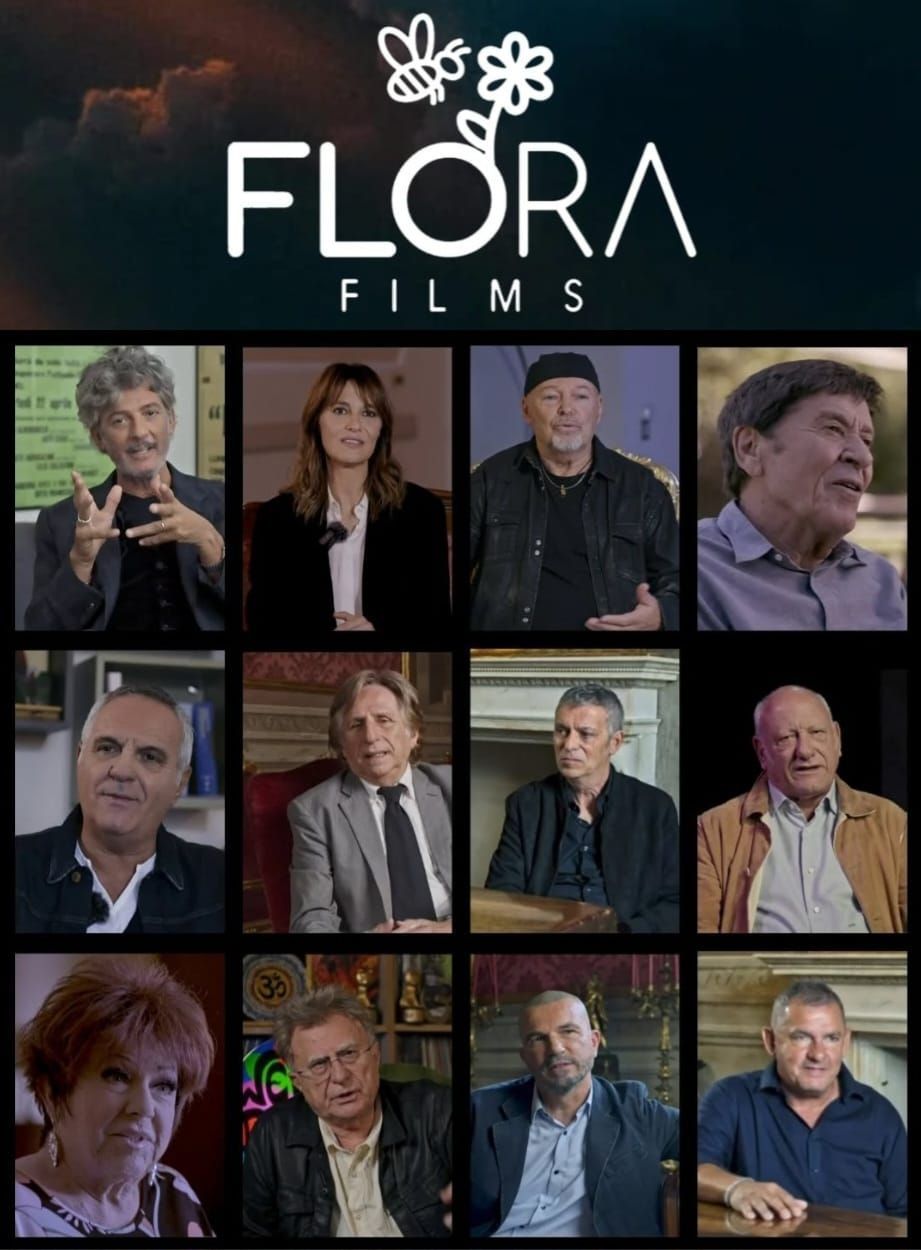2022: fascismo e antifascismo, ha ancora senso parlarne?
2022: fascismo e antifascismo, ha ancora senso parlarne?

‘A volte ritornano’, forse così avrebbe risposto Steven King parafrasando il titolo di una delle sue celebri novelle, ma oltre al piacere narrativo che può trasmettere il maestro del brivido, ripensare agli incontri e scontri ideologici del passato, non ci risparmia una certa apprensione. Se non altro perché poco o niente si riesce ad imparare dalla storia. Come un ultimo fantasma, ritornato dalla tomba, ci ritroviamo ad assistere – per alcuni e subire per altri – alla tragedia di un nuovo conflitto nel cuore dell’Europa dopo che l’umanità s’era ripromessa, dopo la caduta del nazismo, niente più guerra. Invece, sono ritornate le bombe e i crimini contro l’umanità. È pur vero che fino a quando esisteranno governi non democratici il rischio di precipitare nell’abisso non è remoto, ma apporre il sigillo della storia sui mostri del passato, pensando che siano definitivamente sepolti anche in piena democrazia, potrebbe trasformarsi in un grave e pericoloso errore.
A prescindere dagli atteggiamenti folcloristici dei nostalgici di un’epoca, oggi vissuta attraverso le accorate narrazioni di quei pochi a cui il ventennio fascista non ha inflitto sofferenze, esiste un sentimento concreto d’intolleranza e di machismo malato, retaggio dei cattivi esempi, che non disdegna atti di violenza e d’intolleranza per continuare forzare un consenso popolare. Forse le leggerezze di intellettuali del calibro di Noberto Bobbio, per i quali il fascismo non ha avuto una propria ideologia né una vera e propria identità culturale, hanno avuto la conseguenza di dare poco peso al periodo di transizione post-fascista, al punto che in epoca democratica esistono ancora forze politiche incapaci di prendere le distanze da idee e comportamenti che molti vorrebbero relegati al passato e che in realtà fanno sentire ancora la loro influenza.
A partire dagli anni 90 la storiografia italiana ha iniziato a valutare la possibilità che il fascismo sia stato fondato sul consenso degli italiani e di conseguenza, lo stesso consenso, sia stato favorevole a un dibattito antifascista spesso focalizzato sugli stereotipi contrapposti di un paradigma superficiale. La caduta del fascismo per le scelte illiberali e costrittive del regime non è stata vissuta soltanto come il passaggio di consegne tra strutture di potere o come una completa forma di liberazione, ma è stata – per una parte dell’Italia – un trauma sociale, civile ed economico capace di condizionare, ancora oggi, le coscienze inabili a metabolizzare la transizione verso un paese – seppur imperfetto – democratico, il cui maggior pregio risiede nella libertà d’espressione. Per tale motivo, finché i rigurgiti del passato non saranno totalmente assorbiti da una società compatta e consapevole, capace di un giudizio critico, è indispensabile parlare di fascismo e antifascismo, sforzandosi di sciogliere i nodi nostalgici potenzialmente capaci di deviare verso riscorsi storici drammatici e dolorosi.
di Mario Volpe
Share
Tutti gli articoli