I lavoratori giovani in Italia sono una rarità, conversazione con Annamaria Furlan (Pd), ex segretario della CISL
I lavoratori giovani in Italia sono una rarità, conversazione con Annamaria Furlan (Pd), ex segretario della CISL

Secondo i dati raccolti dal Censis: "Nel decennio 2012-2022 gli occupati 15-34enni sono diminuiti del 7,6% e quelli con 35-49 anni del 14,8%"
- Onorevole, vale il detto “L’Italia non è un Paese per giovani?
I dati lo confermano, il fenomeno è in corso da tempo ed è stato più volte evidenziato, ma non adeguatamente affrontato. Come tutti i fenomeni epocali e generazionali, richiede una visione d’insieme e di lungo periodo, che metta in campo una gamma di strumenti articolata e raccordata orientata da un progetto paese, un’idea di sviluppo e di società.
Le ultime crisi sistemiche, quella finanziaria nel 2008 e poi quella pandemica nel 2020, seguite da quella energetica innescata dall’aggressione militare russa dell’Ucraina generatrice di vaste e drammatiche implicazioni, che hanno prima accentuato i trends occupazionali negativi creando devastanti impatti in alcuni settori dei servizi e del turismo a più elevato tasso occupazionale femminile e giovanile, poi si sono scaricate sulla filiera produttiva legata all’interdipendenza delle catena del valore globale, hanno agito su un problema strutturale preesistente.
Tale problema chiama in causa più variabili. Non ultima l’inverno demografico, che non riguarda solo l’Italia, ma che in Italia è molto accentuato e prospetticamente preoccupante.
L’effetto spiazzamento di tutte queste vicende si scarica sulle fasce più deboli ma, lo ripeto, pur essendo nel mezzo di una transizione epocale, incluse quelle digitale e ambientale, sono la progettazione e realizzazione delle infrastrutture sociali, per la famiglia, economiche, educative, di accompagnamento al lavoro che mancano.
È evidente che questo vuoto ci espone più di altri paesi alle crisi esogene, ma ci caratterizza in negativo anche nei periodi di presunta normalità come dimostrano i dati della nostra crescita da circa vent’anni.
- I lavoratori invecchiano e in futuro ce ne saranno sempre meno: si stima che nel 2040 le forze di lavoro nel complesso saranno diminuite dell'1,6%, come esito della radicale transizione demografica che il Paese sta vivendo. Come cambiare tendenza?
La popolazione italiana diminuisce e invecchia. Il rallentamento poi il calo sono sostanzialmente in atto dai primi anni 80 (anche se nella UE è cresciuta sino al 2019 soprattutto beneficiando dell’immigrazione) e la stagnazione è diventata una recessione. I 59,2 milioni di italiani al 1 gennaio 2021 diventeranno 57,9 milioni nel 2030, 54,2 milioni nel 2050 e poco più di 47 milioni nel 2070. Tra il 2001 e il 2020 la popolazione dell’UE a 27 è cresciuta del 4%, per poi arrestarsi e l’Italia è in testa ai paesi con segno negativo
Se poi consideriamo che nel 2050 le previsioni ci dicono che ben il 34,9% degli italiani saranno ultra sessantacinquenni e solo l’11,7% saranno giovani fino a 14 anni, quindi tre ultra sessantacinquenni per ogni ragazzo, e che il 2049 si prevede sarà l’anno in cui i decessi doppieranno le nascite, allora è chiaro che abbiamo di fronte uno squilibrio strutturale, che neppure l’immigrazione, da sola, potrà sovvertire.
Questo significa, ad esempio, più necessità di assistenza, più persone che vivono sole, minore propensione all’innovazione e al cambiamento, un crescente difficoltà nel sostenere adeguate prestazioni previdenziali, la sanità pubblica e universale, una offerta educativa di qualità.
Le indagini effettuate rivelano che siamo il Paese sviluppato in cui è maggiore la distanza tra il numero di figli che le giovani coppie desidererebbero avere (più di 2) e il numero di figli che le stesse coppie effettivamente hanno (meno di 1,3). Detto altrimenti: se non ci fossero ostacoli di sorta, in Italia ci avvicineremmo al tasso di fecondità necessario a mantenere una popolazione stabile anche in assenza di immigrazione, pari a 2,1 figli per donna. Quindi non siamo ancora nella situazione della cosiddetta “trappola della fecondità”, in cui i giovani semplicemente non desiderano avere figli.
Si tratta quindi di intervenire quanto prima perché questo “fertility gap” si riduca. Se esso si riducesse, la nostra popolazione tenderebbe verso un equilibrio demografico, che con una opportuna integrazione migratoria della quale c’è comunque necessità, invertirebbe la tendenza.
Non esistono soluzioni semplici in campo demografico. Un bonus o un assegno in più difficilmente ci convincono ad avere un figlio o una figlia in più.
Ci sono tuttavia esempi positivi ai quali riferirsi. Nei modelli pre pandemici francese e scandinavo, per esempio. Senza entrare nei dettagli, nei loro modelli d’intervento pubblico riscontriamo alcune caratteristiche comuni. Primo: la quantità rilevante di risorse investite. Secondo: la stabilità e continuità nel tempo, agli antipodi dell’una tantum. Terzo: in Francia “pacchetti di misure”, articolati, in grado di intercettare più facilmente diversi gruppi sociali.
E quindi torniamo al ragionamento precedente: serve un modello e che sia stabile. Un insieme di provvedimenti che infondano ai giovani un po’ di ottimismo, che premino, ad esempio, dal mercato del lavoro alla ricerca della casa. Dietro la bassa natalità ci sono sicuramente motivi economici, come la difficoltà a trovare lavoro, ma non possiamo ignorare l’esistenza di motivi anche culturali e percettivi, come la presunzione di assumere un rischio non sostenibile e una scarsa fiducia in un futuro migliore, che non è certo compatibile con il blocco dell’ascensore sociale, con una società nella quale il lavoro è tassato più delle rendite, con una precarietà prolungata, con forti disparità salariali di genere.
- Si legge nel Rapporto Censis che sottolinea che il 64,4% degli occupati dichiara di lavorare solo per ricavare i soldi necessari per vivere e fare le cose che piacciono, senza altre motivazioni esistenziali. Questo vale in particolare per il 69,7% dei giovani. Si lavora senza passione ma per automatismo…
Questo ulteriore aspetto è stato fortemente accentuato dalla crisi pandemica. I ragazzi, ma non solo, hanno riscoperto dimensioni della vita, che hanno reso arcaiche molte delle priorità precedenti profondamente interiorizzate dai modelli produttivi esistenti, sclerotizzatesi a tal punto da agire, esse stessi, come un freno alla crescita della produttività in una perenne rincorsa all’esasperato contenimento dei costi o alla massimizzazione del profitto fine a sé stesso, che tanti danni ha generato a partire dalla crisi finanziaria del 2008.
Non sono solo queste la ragioni a monte della bassa produttività, della crescita dei cosiddetti “lavoretti” deregolati, delle zone grigie dei nuovi lavori gestiti dalle piattaforme, e più in generale della disarticolazione delle imprese e nelle imprese, ma hanno un loro peso non trascurabile.
Detto ciò, tuttavia, é una questione che dovrebbe interrogare in profondità le nostre imprese soprattutto all’alba di una trasformazione tecnologica senza precedenti, che dovrà far leva sulle competenze, sulla duttilità, creatività e motivazione delle persone.
Le strutture verticali e verticistiche, i tradizionali sistemi organizzativi rigidi e settorizzati, il livello delle retribuzioni, i sistemi di welfare integrativo, l’assenza di una cultura della partecipazione e di consolidati strumenti di democrazia economica, persino gli orari di lavoro e le stesse sedi di lavoro tradizionalmente concepite, non sono più compatibili con le aspettative delle persone e con i cambiamenti in corso, il cui tratto distintivo rimanda ad una concezione cooperativa del lavoro, quindi non gerarchica, ma aperta e contributiva.
E poi, vorrei solo accennare ad una ulteriore considerazione. Se il lavoro è vissuto in questo modo, oltre agli aspetti già evidenziati, significa che perde di centralità e di senso riducendosi ad un mero adempimento necessario.
Se il lavoro diventa questo, la società involve e si consegna a dei surrogati di senso molto spesso orientati dalle esigenze consumiste, che plasmeranno persone e poi cittadini su presupposti fluttuanti, privi di ancoraggio ai valori di impegno, realizzazione, responsabilità e contribuzione che il lavoro ha saputo rappresentare per tanto tempo e che, in ultimo, contribuiscono a formare anche un buon cittadino.
Non mi dilungo su ulteriori conseguenze macro strutturali per altro intuibili. Dico solo che non possono esistere società sane, inclusive, solidali se non fondate sul lavoro di qualità.

- Per il 65,0% degli occupati le opportunità di avanzamento professionale sono insufficienti. In secondo luogo, le retribuzioni insoddisfacenti: il 44,2% degli occupati considera lo stipendio percepito non adeguato alle proprie esigenze. C’è un Paese inquieto.
Rispetto a questo tema s’incrociano più questioni e da più punti di vista. Molte rimandano a considerazioni già espresse, che non ripeterò. Mi limito, quindi, ad introdurne alcune altre che, tuttavia, avrebbero necessità di essere ulteriormente articolate e approfondite.
C’è un primo problema oggettivo che riguarda la cosiddetta “questione salariale”. Le retribuzioni sono realisticamente basse in Italia: basti pensare che rispetto al 1990 l’Italia è l’unico paese nell’area UE OCSE in cui i salari sono diminuiti. Se prendiamo a riferimento la Germania + 33,70, la Francia + 31,10, l’Austria + 24,90 e la Danimarca +38,70 e le rapportiamo al – 2,90 dell’Italia, otteniamo la dimensione quantitativa del fenomeno.
Un secondo aspetto deve essere ricercato negli attuali assetti di Governance generalmente refrattari ad aprirsi al lavoro e nella rigidità di molte strutture organizzative la cui conseguenza è l’appiattimento, la disincentivazione, la scarsa dinamicità e apertura alla contribuzione nei processi produttivi e alla partecipazione ai risultati.
Una terza questione è la carenza di risposte alla crescita dei bisogni della persona e della famiglia che un’azienda attrattiva oggi deve mettere in campo, considerati i cambiamenti già intervenuti e in divenire, attraverso forme di welfare integrativo evolute, partecipate e articolate.
Un ulteriore tema riguarda la disintermediazione dei processi, che soprattutto nei servizi, ma non solo, ha spinto la precarizzazione e la compressione dei salari, generando moltitudini di lavoratori poveri senza grandi prospettive.
Infine voglio citare lo scarso raccordo tra scuola-imprese e l’insufficiente investimento in formazione permanente, che se non portati a sistema non potranno alimentare le opportunità e, in ultima istanza, le garanzie. Nel primo caso serve ad avvicinare le due fasi della vita e la domanda e l’offerta di lavoro; nel secondo caso è fondamentale per l’occupabilità nel tempo delle persone, ma anche per sostenerne la capacità contributiva e, implicitamente, lo sviluppo professionale e la crescita retributiva.
All’incrocio di tutte queste variabili c’è la persona attorno alla quale deve necessariamente orbitare un progetto, non estemporaneo finalizzato ad introdurre gli strumenti per aggiornare l’attuale e desueto paradigma, che ha reso il nostro paese meno competitivo, meno attrattivo, meno inclusivo e conseguentemente meno “giusto”.
- C'è poi la paura di perdere il posto di lavoro: teme di potersi ritrovare disoccupato nel prossimo futuro il 42,6% dei lavoratori. In Italia manca la certezza del posto di lavoro.
Anche in questo caso siamo di fronte ad uno dei tanti effetti negativi di quanto già affermato. Bassa crescita, bassa qualificazione, bassa produttività, scarso aggiornamento e, magari, un nucleo famigliare con lavoratori precari o genitori pensionati le cui pensioni subiscono da tempo un carico fiscale tra i più elevati in Europa e il depauperamento per assenza di rivalutazione, sono tutti fattori che alimentano l’incertezza nel futuro.
Deve esistere uno strumento di ultima istanza che intervenga a sostegno delle persone non impiegabili o che, loro malgrado, sono scivolate nell’indigenza; deve anche esistere uno strumento efficace che accompagni le persone nelle transizioni affinché la perdita del lavoro non diventi un dramma irreversibile, ma una parentesi da superare attraverso il reimpiego. I cittadini devono sapere che qualcuno si occuperà di loro nelle avversità e l’obiettivo prioritario, deve essere il rientro nel circuito produttivo.
Tale obiettivo è l’esito ultimo di una strumentazione finalizzata, ma anche dell’esistenza di tutta un’altra serie di condizioni che ho citato in precedenza.
C’è poco da girarci attorno: non supereremo i nostri problemi strutturali e conseguentemente non allevieremo le preoccupazioni delle persone in un caso o le frustrazioni nell’altro, se non attraverso un progetto paese di medio periodo, che si fondi sulla persona e sul lavoro in un quadro di sostenibilità sociale e ambientale. Il PNRR, a questo proposito, è un’occasione irripetibile.
Lo smarrimento e la sfiducia indeboliscono la coesione sociale e la qualità della democrazia. Creano instabilità, derive pericolose e crescenti sacche di marginalità.
Altro che misure tampone. È ben altro che occorre. Un tempo lo avremmo definito “spirito costituente”, che difficilmente può coniugarsi con la ricerca quotidiana del consenso attraverso operazioni di distrazione di massa.
- L’innovazione tecnologica farà aumentare questa tensione sociale? Penso all’intelligenza artificiale o all’industria 4.0
Dipende. L’innovazione la si può subire e allora sono dolori, perché genera un effetto spiazzamento, che può addirittura rendere obsoleta in poco tempo una intera generazione nei più svariati campi e nelle infinite applicazioni che ne discendono. La tecnologia digitale è veloce, esponenziale e combinatoria. Sono illimitate le sue applicazioni e combinazioni.
Oppure la si orientare, governare, democratizzare e allora diventa un formidabile strumento di inclusione e di emancipazione, perché abbatte le barriere fisiche e geografiche, è fruibile ai più, consente opportunità diffuse e riduce i costi. Certo, prima ci sono gli investimenti da fare, ma poi le economie di scala sono impressionanti.
Ecco, bisogna prepararsi e preparare le persone. Bisogna creare strumenti di accompagnamento e sostegno. Bisogno alfabetizzare e formare. Bisogna orientare la tecnologia a tutto ciò che facilita la qualità della vita e del lavoro.
Tecnologia vs umanità è una contrapposizione sbagliata pari solo all’ideologia del determinismo tecnologico.
Vedo all’orizzonte un rischio che voglio esplicitare: non si devono saldare il potere finanziario e quello tecnologico, perché una simile concentrazione creerebbe monopoli ed enormi concentrazioni di ricchezza e di potere. Sotto questo punto di vista l’Europa può e deve fare la propria parte.

- Molti dicono che sia più produttivo lavorare 4 giornate alla settimana. È conciliabile coi conti pubblici?
Non vedo quale sia il nesso. Esistono già delle esperienze in questo senso e la produttività è addirittura aumentata. Figuriamoci poi nell’era digitale.
Rimarranno delle eccezioni, com’è ovvio che sia, ma l’era digitale cambia un paradigma di fondo: il luogo fisico di lavoro come totem della società dell’economia post industriale.
Casomai dovremo porci il problema opposto. Se molti lavori non ne avranno più bisogno, come garantiamo la relazione tra le persone, l’interscambio, l’alimentazione di quel valore aggiunto, che solo l’intelligenza collettiva sa produrre?
Come alimentiamo i processi collettivi, la condivisione, la partecipazione, l’identificazione in un progetto che sia imprenditoriale, o anche di comunità?
Ecco, la tecnologia richiede nuovi strumenti per alimentare le comunità di pratiche, di relazione e d’interscambio. Esige forme di umanizzazione, che non sostituiscano la persona con un algoritmo, la relazione con un post, lo scambio con un tweet.
- Migliaia di lavoratori hanno abbandonato la tessera del sindacato. Questo non svolge più oggi la sua primaria funzione di tutela del lavoratore. Di questo scompariranno le parti sociali o si reinventeranno?
Sono stata sino ad alcuni anni fa la segretaria Generale della CISL, una grande organizzazione sindacale confederale di oltre quattro milioni di iscritti con prevalenza di lavoratori attivi. Oggi svolgo altre funzioni, pur servendo i medesimi valori, quindi questa domanda non andrebbe posta a me.
Tuttavia posso dirle che il dato dell’emorragia macroscopica da Lei citato non mi risulta, almeno in Italia. Anzi.
Ciò promesso, è ovvio che tutti i grandi soggetti di rappresentanza, siano essi imprenditoriali o sindacali sono profondamente interrogati dai cambiamenti in atto.
Le posso dire che le disfunzioni dell’attuale modello, la CISL le ha evidenziate ripetutamente nel tempo accompagnandole con proposte concrete com’è nello stile di un grande sindacato che fa dell’autonomia, della pragmaticità, della solidarietà, della partecipazione, del riformismo i grandi baricentri della propria azione. Potrei citarle innumerevoli esempi, ma tradirei la premessa alla mia risposta.
Posso dirle, tuttavia, che essendo cambiata la società, il lavoro, l’economia cambiano necessariamente anche le azioni di tutela e rappresentanza.
Agire politiche di solidarietà o di emancipazione negli anni 70 richiedeva strumenti che oggi sarebbero anacronistici per i medesimi obiettivi.
Se avessimo la pazienza di rileggere le argomentazioni che ho espresso in precedenza troveremmo molte delle risposte alla sua domanda.
Chiudo con una considerazione: i contesti cambiano, le organizzazioni evolvono e gli strumenti necessariamente si modificano. In passato, ad esempio, non avremmo potuto immaginare la rilevanza che hanno assunto i servizi agli associati e voglio qui ricordare quale opera meritoria abbiano svolto come punto di riferimento nel durante delle varie crisi che si susseguono dal 2008, anche e soprattutto nelle periferie. Le persone vi hanno trovato un punto di riferimento importante, forse l’unico in alcuni momenti.
Quindi direi che l’azione di tutela si è ampliata e non ristretta, pur agendo su piani non sempre tradizionali.
Oggi più che mai serve un grande e autorevole sindacato confederale, che da un lato deve contribuire a governare le grandi trasformazioni orientandole alla persona e al lavoro e dall’altro realizzare l’obiettivo storico della partecipazione del lavoro per una condivisione dei processi e una più equa distribuzione del valore generato e delle opportunità di cui, tra l’altro, l’economia della conoscenza ha estremamente necessità.
O vogliamo lasciarla al libero mercato? Mi pare che abbia già dimostrato più volte di non essere la soluzione.
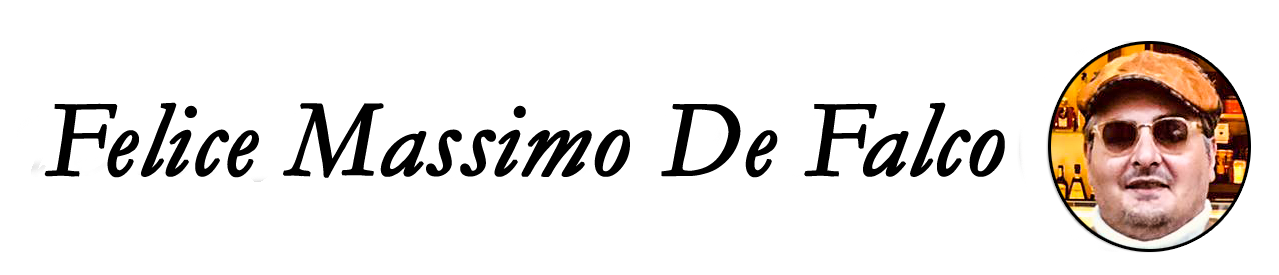
Share
Tutti gli articoli












