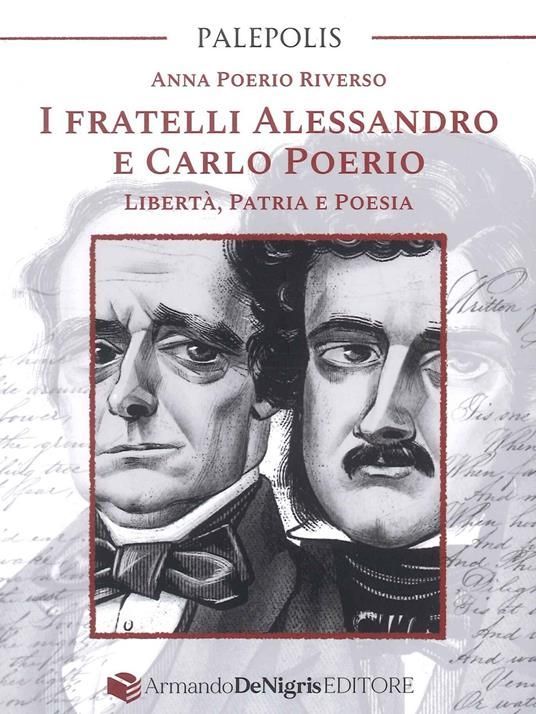Life on Mars? - a cura di Vittorio Schiavone - "Eufemia (scusate l'eufemismo)" - Il borderline
Parliamo col dott. Vittorio Schiavone, primario alla Clinica Hermitage di Capodimonte (Na), di disturbo bordeline di personalità, troppo spesso assegnato ai pazienti i quali si sentono quasi in diritto di esser come sono. Una sorta di patente sociale che giustifica ogni loro comportamento. Una diagnosi "figlia della rassegnazione, o della comodità, magari; o figlia di una diagnosi sparata con troppa leggerezza o superficialità. Una diagnosi che, per quanto corretta, non centra il suo bersaglio, anzi colpisce un bersaglio collaterale. Come una bomba che colpisce un ospedale; ma anche se colpisse un deposito di armi, credetemi, sarebbe sbagliata lo stesso, perché sono le bombe e le guerre ad essere un’aberrazione. Proprio come certe diagnosi sganciate su pazienti e familiari, con la leggerezza di un bottone che viene premuto".

“Che ci posso fare, Dottore? Io sono così”.
Tutti i guai del mondo, beh, forse non tutti ma almeno i più grossi, iniziano con una frase come questa. Una frase come questa figlia della rassegnazione, o della comodità, magari; o figlia di una diagnosi sparata con troppa leggerezza o superficialità. Una diagnosi che, per quanto corretta, non centra il suo bersaglio, anzi colpisce un bersaglio collaterale. Come una bomba che colpisce un ospedale; ma anche se colpisse un deposito di armi, credetemi, sarebbe sbagliata lo stesso, perché sono le bombe e le guerre ad essere un’aberrazione. Proprio come certe diagnosi sganciate su pazienti e familiari, con la leggerezza di un bottone che viene premuto.
Bisognerebbe guardare in faccia i morti ed i loro familiari; ma essere umani non te lo inventi da un giorno all’altro, come succede invece quando ricevi una diagnosi che legittima il tuo essere “disturbato”. Una sorta di lasciapassare per ogni cazzata che tu possa aver fatto o possa fare, quasi un incentivo ad ogni forma di sano tentativo di cambiamento. Ecco cosa sono certe diagnosi, una patente: una patente che dura a vita e che non ha bisogno di revisioni, un certificato che dice “io sono così, prendere o lasciare”.
Lasciano tutti, prima o poi, legittimati anch’essi da quelle paroline scritte su quel foglietto di carta intestato; e si invoca il destino, come se esistesse davvero, e a lui si dà una colpa che non c’è. Perché in psichiatria non ci sono colpe da distribuire, ma persone da aiutare, per quanto possibile, a vivere meglio.

Questa è la storia di Eufemia, ma potrebbe essere quella di Lella , Pietro o Gianfranco. La storia di ragazzi cui si aveva l’impellenza di attribuire una diagnosi di disturbo borderline affinché il mondo trovasse pace: sono pazzi, fatevene una ragione. Giustificate, dunque, la loro instabilità, sentimentale e d’umore, il loro non rispettare le regole, la loro incostanza, le droghe e gli eccessi. Giustificate ogni comportamento a rischio, il non voler fare un cazzo dalla mattina alla sera, i progetti grandiosi e le rovinose cadute, il bianco ed il nero, senza sfumature. Giustificate l’amore viscerale e l’odio profondo, giustificate il mondo che non li vuole. Perché, quando si accetta una condizione senza sentirsi in dovere di fare nulla per cambiare, il mondo la può rigettare altrettanto: ecco che la diagnosi diventa sì una legittimazione, ma soltanto del rifiuto del mondo. Di quel mondo che aveva bisogno di sapere non per aiuto ma per trovare pace, per essere legittimato a giudicare un libro dalla copertina. Un libro è un libro, e se è brutto resterà tale; ma una persona?
Lo psichiatra è forse l’unica persona che ti conosce davvero e, ciononostante, continua a volere avere a che fare con te. Lo fa perché è il suo lavoro, certamente, ma lo fa anche perché è scevro da ogni pregiudizio. Per uno psichiatra la diagnosi è solo l’inizio di un processo di cura: lui guarda sempre dove si può arrivare. Non importa se sarà un percorso di “sangue e merda”, come direbbe Zerocalcare o se si dovrà scardinare l’idea della “nevrosi di destino”, come direbbe Freud in una maniera di certo più colorita della prima. Allo psichiatra non importa altro che del suo paziente. È ovvio che per non essere più delirante dei deliri che tratta lui si porrà, e porrà dunque al paziente ed ai familiari, solo obiettivi possibili. La guarigione, come l’amore e l’andare al mare d’estate non sono forse concetti sopravvalutati? Qui si lavora per stare al meglio possibile, non per inseguire sogni di ricchezza. Stare male capita purtroppo nella vita: non si può fare finta che non sia accaduto e bisogna fare i conti con il dopo la malattia, non con il prima. Non siamo più quelli di prima, ma non siamo neppure ancora ciò che possiamo diventare, grazie a Dio.
C’è margine, dunque, e c’è margine partendo dai pregiudizi, dalle idee assolute, dalle premesse del micro mondo familiare e di quello più allargato. C’è margine partendo dal distinguere ciò che è patologico da ciò che non lo è, ciò che è modificabile da ciò per cui non basterebbe un miracolo da cento punti. C’è margine partendo dalla relazione, dalla comunicazione, dalla cooperazione, dalla tendenza assurda e pericolosa di psichiatrizzare e patologizzare ogni cosa. Agli psichiatri le diagnosi, ai familiari il buon senso. Ma quanto è difficile! Quanto è difficile far capire ad un genitore che ciò che a lui pare uguale in un caso è un sintomo, mentre in un altro non lo è! Quanto è difficile fargli capire che deve fare il genitore, e non lo psichiatra, mentre lo psichiatra fa lo psichiatra, e non il genitore. Quanto è difficile fargli capire che una patologia non conferisce una immunità diplomatica dalle regole e dalla buona educazione. Quanto è difficile, talvolta, fargli capire che una patologia non lo esime da fare il genitore. Un lavoro sporco e difficile, ma che qualcuno, cioè lui, deve pur fare. Ecco che la diagnosi viene in soccorso a dare una spiegazione ed una giustificazione a tutte le difficoltà; è umano, ma è controproducente. E lo è ancora di più quando tuo figlio non vede i mostri, ma sembra solo un pò più “difficile” degli altri. La diagnosi è l’inizio di un processo di cura, lo dicevo prima, non la fine.
“Sì, sei una stronza, ed uso un eufemismo. Sai come si cura la stronzaggine? Con i paccheri (schiaffi ad altre latitudini, ndr), metaforici e non. Sei così? Se non ti sta bene, prova a cambiare, essere stronzi non è una malattia dell’obbligo. Non vuoi cambiare? Allora non ti lamentare che tutti ti schifano, funziona così”.
“Ma io sono borderline!”.
“Non ne andrei così fiera”. Certe volte i paccheri ci vorrebbero anche per chi diagnostica, senza pensarci troppo, o per legittima difesa.

Share
Tutti gli articoli