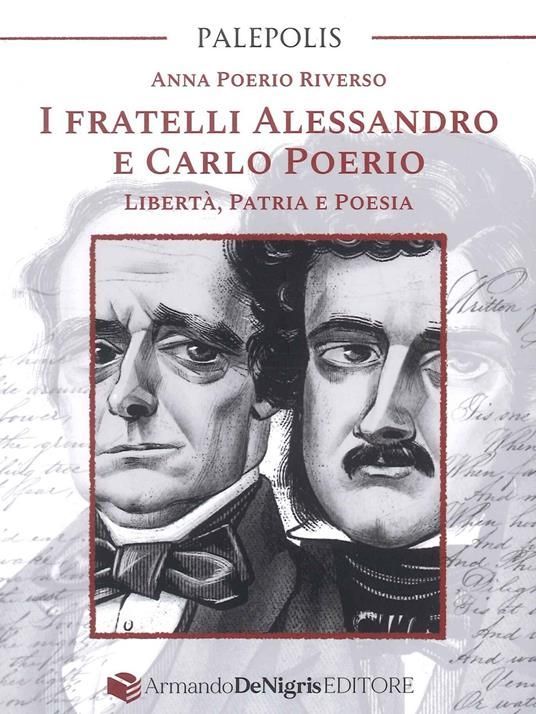Life on Mars? - L'istrione - a cura dello psichiatra Vittorio Schiavone
È il dolore di chi grida “al lupo!”, quando il lupo non c’è. È la necessità delle maschere del teatro kabuki di farsi riconoscere a metri e metri di distanza. È una stanza vuota in cui si viene soffocati dalla solitudine. Perché l’istrionico (chiamiamo le cose con il loro nome) ci fa tanta rabbia? Perché la sua sofferenza non ci arriva autentica. Non ci arriva nulla di quella solitudine: tutto ciò che ci arriva è una esibizione esagerata di una sofferenza simulata, un fondale di cartapesta, un effetto speciale fatto con i petardi. La sua rappresentazione è così inautentica che non riesce a risuonare con nessun sentimento simile dentro di noi, attivando una difesa rabbiosa volta ad allontanare lo stimolo fastidioso. Ci fa incazzare, in poche parole. E questa nostra reazione non fa altro che costringere il nostro ad alzare il tiro, nella speranza vana che sia una questione di quantità e non di qualità. Non è così, ovviamente, e pertanto la storia è destinata a ripetersi.

“Non sono mai stato così male, Dottore”. Il dolore vero puzza di cipolle: quando lo senti, non puoi fare a meno di lacrimare. Importa poco se siano lacrime interne od esterne, non può lasciarti indifferente: ti smuove qualcosa dentro che va in risonanza con il mondo e tu ti ritrovi a soffrire, per quanto puoi, della stessa sofferenza di chi ti sta davanti. Se le lacrime non sortiscono questo effetto, può voler dire soltanto due cose: o che non sono autentiche, o che sei ad esse impermeabile.
Nel caso di uno psichiatra, la seconda possibilità non è compatibile con la professione perché altera il giudizio clinico. Ma questa è un’altra storia. Nicola esibiva sempre la sua sofferenza: a me, ai suoi familiari, agli amici, al mondo. Eravamo tutti sui spettatori inconsapevoli, non avendo scelto di recarci a questa rappresentazione né essendoci assunti l’onere del biglietto di ingresso. Il prezzo pagato, nel caso delle sue relazioni affettive, era volergli bene; nel mio, quello di aver scelto, più di venti anni fa, psichiatria invece di radiologia perché “non volevo perdere il contatto con il paziente”.
Chi mi ha cecato (espressione intraducibile che esprime sommo disappunto per una scelta effettuata in passato che, al giorno d’oggi, non è portata avanti con la stessa convinzione). Esibire funziona. Ricordo ancora, quando mi occupavo di valutazioni medico-legali per l’INPS , la preoccupazione di tutto lo staff, medico e non, per una signora che mi chiesero di valutare nel parcheggio in quanto non riusciva a deambulare e doveva essere sorretta da due persone per coprire anche piccole distanze. Dopo uno sguardo veloce alla documentazione presentata, una accozzaglia di diagnosi psichiatriche senza né capo né coda accompagnata da terapie altrettanto rozze, dissi che non avrei potuto svolgere la valutazione se non nella mia stanza.
La paziente entrò sorretta ipoteticamente da due persone. Non aveva nulla di neurologico, né nulla di invalidante dal punto di vista motorio: aveva una grande sofferenza che doveva essere enfatizzata per essere creduta perché, come uno spaghetto aglio ed olio fatto male, sapeva di poco. Qual è questa sofferenza? L’essere ignorati. Possiamo discutere se essa sia una patologia degna di attenzione o meno (interessante il gioco di parole), ma non c’è dubbio alcuno che provochi sofferenza nell’ignorato. È il dolore del bambino che dice, emozionato, “mamma, guardami!”, mentre la mamma rivolge il suo sguardo altrove come se non esistesse.

È il dolore di chi grida “al lupo!”, quando il lupo non c’è. È la necessità delle maschere del teatro kabuki di farsi riconoscere a metri e metri di distanza. È una stanza vuota in cui si viene soffocati dalla solitudine. Perché l’istrionico (chiamiamo le cose con il loro nome) ci fa tanta rabbia? Perché la sua sofferenza non ci arriva autentica. Non ci arriva nulla di quella solitudine: tutto ciò che ci arriva è una esibizione esagerata di una sofferenza simulata, un fondale di cartapesta, un effetto speciale fatto con i petardi.
La sua rappresentazione è così inautentica che non riesce a risuonare con nessun sentimento simile dentro di noi, attivando una difesa rabbiosa volta ad allontanare lo stimolo fastidioso. Ci fa incazzare, in poche parole. E questa nostra reazione non fa altro che costringere il nostro ad alzare il tiro, nella speranza vana che sia una questione di quantità e non di qualità. Non è così, ovviamente, e pertanto la storia è destinata a ripetersi.
Ma, se l’analisi “contro-transferale” è diagnostica e, pertanto, terapeutica, essa è appannaggio dei soli addetti ai lavori; nella vita di tutti i giorni, questa sofferenza da romanzo scritto male divide il mondo in indifferenti (le relazioni) ed accusatori degli indifferenti (tutti gli altri), pronti a condannare i primi per la loro crudeltà, salvo poi a cambiare strada pur di non incrociare quel tizio che “si lamenta sempre”. Si è tutti psichiatri nello studio degli altri. “Ti stai sottovalutando, Nicola: sono certo che domani potrai fare di meglio”. No, non sono uno stronzo: sono uno psichiatra.

Share
Tutti gli articoli