Intervista all'Avv. Domenico Ciruzzi (Pace, Terra, Dignità):" La separazione delle carriere non è epocale, il nodo resta avere giudici più colti"
Il noto penalista napoletano, oggi candidato all'EuroParlamento per "Pace, Terra e Dignità" interviene sul tema della riforma della separazione delle carriere, il caso-Toti, l'esigenza di avere la pace nelle aree di conflitto e affronta il tema della dignità: "Dignità significa riconoscere (e proteggere) il diritto di ogni cittadino, anzi di ogni individuo, ad un lavoro, ad una casa, alla salute, ad una vecchiaia serena, alla pace, alla libertà nei confronti di ogni potere politico, economico o criminale che sia. Significa, in altri termini, dare piena applicazione all’art. 3 della nostra Carta costituzionale. Assicurare ad ogni individuo la dignità è il fine ultimo della politica, l’unico vero motivo per il quale gli uomini hanno architettato una procedura così complessa, talvolta farraginosa e sempre costosa.

Domenico Ciruzzi, noto penalista napoletano, radici lucane, natali leccesi, napoletano da sempre, ha iniziato allo studio del compianto Vincenzo Siniscalchi. Come avvocato si è occupato di tutto, dalla camorra al terrorismo, talvolta come parte civile. Insegna alle scuole di specializzazione di Giurisprudenza (Federico II) ed è stato consigliere dell’Ordine dal ’99 al 2003 e presidente della Camera penale dal 2004 al 2006. Nella fase iniziale è stato l'avvocato del Mattino come parte civile nel processo Siani. Ha scritto testi per la tv ed è autore e regista di teatro e di cortometraggi.
Oggi è candidato all'Europarlamento con la lista "Pace, Terra e Dignità". Abbiamo raccolto il suo autorevole parere su alcuni temi centrali di attualità: dalla giustizia passando per la politica e la guerra. Ecco cosa ha detto.
Avvocato Ciruzzi, lei è un noto avvocato penalista e spesso critico col potere invasivo della magistratura. La Riforma Nordio, secondo lei, attenua o addirittura blocca l’ingerenza illimitata di alcune frange di magistrati?
La separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti è il logico – direi quasi ovvio – corollario del processo accusatorio che abbiamo scelto ormai trentacinque anni fa, avendo preso atto che il rito inquisitorio risultava incompatibile con una società contemporanea ed era foriero di tanti, troppi, errori giudiziari.
Trentacinque anni fa fu fatta una scelta, peraltro a parere di quasi tutti corretta, e le scelte (ed i relativi sistemi) devono essere conseguenti: il processo accusatorio è un processo di parti contrapposte che agiscono in una condizione di parità e, pertanto, presuppone necessariamente l’esistenza di un giudice che sia terzo e non abbia alcun legame con alcuna delle parti in causa. Un giudice che – occorre sempre evidenziarlo – a differenza del P.M. non rappresenta lo Stato ed il suo apparato ma è garante del rispetto dei diritti del popolo.
Ora, è evidente che se il giudice condivide con il pubblico ministero la carriera, la formazione ed anche una certa visione del mondo e del diritto non potrà mai essere né apparire davvero imparziale.
Dunque è nella logica delle cose che la separazione venga attuata ed anzi è anomalo (ed è su questa anomalia che occorrerebbe incentrare il dibattito pubblico) che ancora oggi – a distanza di oltre 30 anni dall’entrata in vigore del “nuovo” codice – se ne stia ancora a discutere.
Ciò detto, non credo che la finalità – almeno non quella principale - della separazione delle carriere sia quella di limitare l’ingerenza ed il potere di Pubblici Ministeri particolarmente “arrembanti”. Lo scopo è a mio parere quello di tendere ad una giustizia più giusta e garantita, di migliorare le professionalità (in particolare quella del giudicante) e soprattutto di far recuperare fiducia ai cittadini che, da lungo tempo, mostrano – e non soltanto per alcuni scandali che si sono verificati negli ultimi anni - chiari segnali di insofferenza e di sfiducia nei confronti della giustizia nel suo complesso.
Ed una giustizia che non gode della fiducia dei suoi cittadini, che non è autorevole, degrada a mero atto di imperio che non può durare a lungo all’interno di una cornice democratica.
È una riforma epocale?
No, non lo è.
Intendiamoci, non è un vessillo o una battaglia ideologica dei penalisti e di taluni, invero spesso mutevoli, partiti politici.
La separazione delle carriere è potenzialmente idonea a produrre effetti concreti sia pur, credo, più in un’ottica prospettica che nell’immediato futuro atteso che tutti i giudici attualmente in servizio si sono formati nel contesto “consociativo” testè evidenziato e dunque risentono (ovviamente non tutti ma una buona parte sì) dell’humus in cui si sono formati professionalmente.
Ma, al netto di ciò, da sola la separazione non è in grado di modificare sensibilmente in positivo la qualità e l’autorevolezza della giustizia penale
La separazione delle carriere, però, può avere un ruolo servente e di impulso rispetto a quello che, a mio parere, costituisce il vero punctum dolens della giustizia e del processo penale in questo momento e cioè un certo deficit culturale e di autorevolezza della magistratura giudicante che talvolta sembra aver smarrito il perimetro ed il senso altissimo e “terribile” del giudicare.
Il tasso culturale, inteso come affinamento della sensibilità per capire la complessità del mondo, è mediamente aumentato tra gli avvocati ed i Pubblici Ministeri, checché se ne dica.
È spesso precipitato invece quello del giudice, il professionista dell’indipendenza e dell’autonomia, colui il quale dovrebbe essere ed apparire indipendente, e dunque al di sopra delle parti senza soccombere ai desiderata di altri poteri, in special modo di quelli di volta in volta al governo.
In una contemporaneità così complessa, il giudice dovrebbe essere il più colto, il “Migliore”, per poter svolgere il suo difficilissimo compito con indipendenza ed autonomia.
Ed oggi tendenzialmente non sempre lo è, salvo pregevoli eccezioni.
Mediamente, il PM contemporaneo è cresciuto di più culturalmente: il contatto diretto e comunque più vicino con i “corpi” ed il dolore degli inquisiti e dei loro familiari, il rapporto dialettico, anche aspro, con i difensori, gli “scambi” di opinioni, e non solo, con i media hanno fatto si, pur tra errori e fuorvianti esercizi di potere, che il PM abbia maggiore consapevolezza di come vadano le cose ed abbia affinato la sensibilità finanche nella dosimetria della pena.
Non sono, a mio parere, né il PM né i media il problema oggi più urgente del processo penale contemporaneo ma la sempre più diffusa insufficienza culturale del giudicante: sovente, infatti, risulta incapace di decrittare i molteplici mosaici di interferenze che investono lo scenario del processo, non ponendo un argine alle molteplici richieste degli assunti accusatori ed alle pressioni dei media che recepiscono tendenzialmente i sussulti colpevolisti dei tanti sempre pronti a “riservare l’infamia penalistica agli altri”.
Convalidare fermi ed arresti, autorizzare intercettazioni telefoniche o ambientali, perquisizioni e sequestri, concedere proroghe d’indagini e pedisseque conferme in sede di Riesame, disporre rinvii a giudizio senza alcun controllo pervicace, significa rimanere soffocati poi in dibattimento dalla proliferazione di carte processuali, come topi in trappola.
Taluni giudici, non ponendo un argine alla produzione di montagne di faldoni, vengono successivamente travolti in dibattimento da slavine cartacee di milioni di pagine che non consentono nessuna sintesi, e dunque sovente nessuna ponderata decisione.
Ma perché ciò accade? Perché il giudice mediamente oggi non è più colto, non è sempre il migliore. Non sa più operare connessioni, talvolta privo di autentica cultura umanistica e munito solo di iperspecializzazione fin dal superamento delle prove d’accesso che premiano l’esegeta delle minuzie interstiziali e non l’interprete del ragionamento ampio e complessivo.
Il rischio è che il giudice, da persona coltissima capace di leggere ed interpretare il Mondo più dolente, oscuro e complesso ex art. 3 Cost., si trasformi sempre più in un topolino che annaspa tra le carte.
Ecco, io credo che la separazione delle carriere – che andrà accompagnata anche da una seria e ponderata riforma delle modalità di reclutamento soprattutto della magistratura giudicante, con la previsione di concorsi differenziati anche sotto il profilo del contenuto – possa costituire uno strumento ed un pungolo per migliorare la qualità della magistratura giudicante.
Se ciò non dovesse, tuttavia, avvenire la riforma in discussione potrebbe addirittura peggiorare la qualità della giurisdizione poiché, a quel punto, una magistratura giudicante imbelle e non adeguatamente attrezzata rischierebbe davvero di essere surclassata dal potere delle Procure che, non va dimenticato, hanno pur sempre dietro di sé tutto l’apparato (repressivo e non solo) dello Stato.
Lei, da uomo di sinistra, candidato con Pace, Terra e Dignità all'Europarlamento, se fosse in Parlamento, favorirebbe l’iter di approvazione col suo voto?
Beh, diciamo che in astratto il problema non si pone nel senso che, qualora dovessi essere eletto, lo sarei a Bruxelles dove non potrei in alcun modo votare la riforma.
Ma ovviamente non mi sottraggo alla sua domanda per quanto meramente ipotetica.
Si, pur con le preoccupazioni che ho appena espresso, credo che mi adopererei per favorire l’iter di approvazione della legge, cercando di modificare alcuni passaggi del disegno di legge costituzionale che proprio non mi convincono.
In particolare, trovo davvero inaccettabile la previsione della nomina al CSM attraverso il sorteggio – una sorta di riffa – che mortifica principi democratici secondo me basilari.
E sul punto mi chiedo: se si ritiene addirittura che i giudici non siano in grado, non abbiano adeguate qualità etiche e morali neppure per eleggere i propri rappresentanti (ed io sono convinto che, al netto di talune “cadute” del recente passato, non sia così) come si può pensare che possano decidere le sorti dei cittadini, imputati o parti offese che siano?
E su questa riforma – e non già sulla separazione delle carriere – i magistrati dovrebbero legittimamente insorgere.
Cosa pensa del caso Toti? Siamo di fronte ad una sorta di sequestro di persona?
Del caso Toti non so null’altro di quello che ho letto sui giornali e, pertanto, non intendo né posso esprimermi concretamente sull’argomento.
In generale ed in termini astratti, il fatto che gli eventuali versamenti siano tutti tracciati e costituiscano finanziamenti elettorali non impedisce in termini assoluti che si possa essere al cospetto di fatti di corruzione anche se obiettivamente sono circostanze che rendono più plausibile la liceità dell’operazione.
Ma al di là del dato strictu sensu giudiziario – che sarà vagliato, mi auspico accuratamente, nelle sedi competenti – quello che trovo davvero insopportabile è la gazzarra mediatica e politica che sempre si solleva in casi del genere.
Si utilizza un “fattoide” – e cioè un fatto ancora da dimostrare e prima ancora che sia potuta intervenire la difesa – per far partire campagne di stampa e soprattutto politiche che si concludono sempre con la richiesta di dimissioni.
Ed il concetto e la costruzione della frase è sempre lo stesso: “siamo garantisti (sic!), l’eventuale rilevanza penale sarà stabilita dal giudice, ma ragioni di opportunità politica impongono le dimissioni perché sono emersi comunque elementi di opacità”.
Queste frasi e questi concetti sono ripetuti mille volte, tanto che – anestetizzati dal rumore di sottofondo – si finisce spesso per non coglierne l’intrinseca stupidità (oltre che l’evidente ipocrisia).
Ed invero – e fermo restando che la cernita sulle candidature deve essere prudente e ponderata da parte di tutti i partiti politici - se siamo nell’ambito della mitologica categoria dell’opportunità politica allora è evidente che la valutazione sull’operato del singolo politico o amministratore pubblico non può spettare certamente all’editorialista o all’avversario politico di turno ma esclusivamente ai cittadini che, al momento del voto, valuteranno se quelle condotte, non penalmente rilevanti, siano comunque scarsamente compatibili con l’esercizio della carica pubblica.
Quali sono i temi più cari a lei che vuole portare sui banchi di Bruxelles?
In questo momento storico credo che il tema della pace sia quello fondamentale.
La pace costituisce la pre-condizione per l’esercizio di ogni altro diritto. Senza pace non può esservi giustizia, libertà, uguaglianza.
I demoni della guerra si aggirano per l’Europa (e non solo) e, oltre a portare morte e distruzione, non potranno che comprimere – come sempre è avvenuto - i diritti fondamentali degli individui. Dunque se non si inverte questa tendenza, se non si pone fine a questa insulsa escalation bellicista si avrà un regresso delle libertà e dei diritti – anche di quelli ritenuti, a torto, definitivamente acquisiti - in tutta Europa e probabilmente in tutto il Mondo.
E sulla pace credo che l’Europa possa fare molto se lo vuole.
Accanto alla pace, vi è ovviamente il tema della giustizia a me sempre caro.
Sul punto, credo che siano maturi i tempi per iniziare ad immaginare e progettare una giustizia di stampo e respiro europeo in cui, pur nel rispetto delle specificità e delle tradizioni dei singoli Stati membri, si individui un nucleo fondamentale ed inderogabile di diritti e di garanzie valido su tutto il territorio del nostro continente.
Ecco, io auspico che, in tempi brevi, non saremo più costretti a vedere immagini feroci e pre-moderne di individui portati in ceppi ed al guinzaglio dinanzi al giudice.
Ma vede anche nella civilissima Italia – che qualcuno ancora definisce la culla del diritto – esistono istituti che si pongono in palese contrasto con i principi europei ed, invero, anche costituzionali: penso in particolare al sistema delle misure di prevenzione, all’ergastolo ostativo (quello “vero” che non ha mai fine) che incredibilmente ancora esiste nonostante la dura presa di posizione della Corte Costituzionale, alle carceri che scoppiano di poveri e di disperati, luoghi in cui tra scarafaggi, psicofarmaci e suicidi si fa scempio dei principi costituzionali ed, ancor prima, dei principi di umanità.
Da ultimo, credo che sia doveroso – anche in Europa – impegnarsi a tutela dei cittadini del Sud del nostro Paese; Sud che la scellerata riforma dell’autonomia differenziata rischia di far precipitare in un baratro di povertà e di disperazione i cui effetti permarranno per decenni.
Lei si batte per la pace. Ci sono tanti conflitti in questo momento nel mondo. Secondo lei, come si ottiene la tregua?
Innanzitutto, convincendosi che la guerra non è mai un modo per risolvere i conflitti e che – checchè qualcuno ne dica – la guerra per sua natura non porta mai alla pace. La guerra, come ci insegna tutta la storia della prima metà del Novecento, si autoalimenta e cresce sempre più di intensità, fino al punto di non ritorno. Spero davvero che non si debba giungere, come nel secolo scorso, alla bomba atomica per comprendere un concetto di per sé invero non particolarmente complesso.
In secondo luogo, occorrono energiche e ragionate iniziative diplomatiche con la consapevolezza che non esistono ricette valide e spendibili in ogni occasione ed in ogni contesto.
Ma in ogni caso non è possibile rassegnarsi – come invece sembra che stia accadendo – all’inevitabilità della guerra.
Cosa intende per dignità?
Dignità è la parola, il concetto fulcro di ogni effettiva democrazia.
Dignità significa riconoscere (e proteggere) il diritto di ogni cittadino, anzi di ogni individuo, ad un lavoro, ad una casa, alla salute, ad una vecchiaia serena, alla pace, alla libertà nei confronti di ogni potere politico, economico o criminale che sia.
Significa, in altri termini, dare piena applicazione all’art. 3 della nostra Carta costituzionale.
Assicurare ad ogni individuo la dignità è il fine ultimo della politica, l’unico vero motivo per il quale gli uomini hanno architettato una procedura così complessa, talvolta farraginosa e sempre costosa.
Ora, senza fughe retoriche ma con onestà e nettezza di pensiero dobbiamo chiederci se oggi la dignità dei cittadini sia effettivamente salvaguardata ed in quali forme e gradi.
Io credo di no – o comunque non abbastanza – e questo è il motivo della disaffezione sempre più crescente dei cittadini nei confronti della politica che produce l’effetto (non l’unico ma sicuramente il più visibile e “rumoroso”) di un astensionismo che ha raggiunto vette inimmaginabili solo 15/20 anni fa.
Ma fuori dalla politica – è bene ricordarlo - non vi può che essere l’ “uomo forte”, la democratura ed, in ultima analisi, la dittatura.
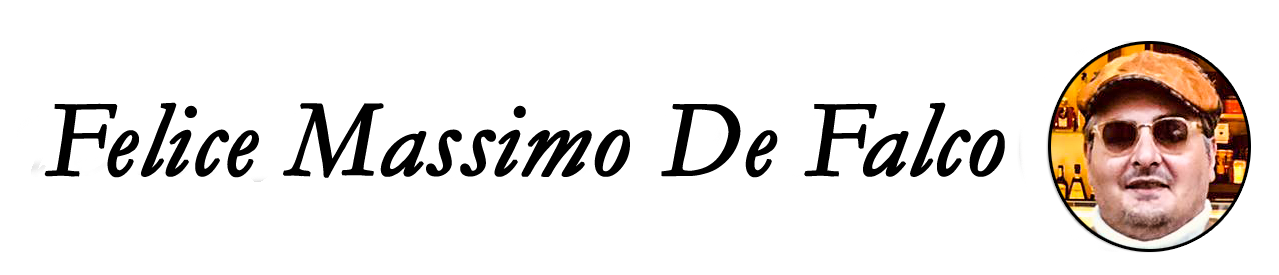
Share
Tutti gli articoli












