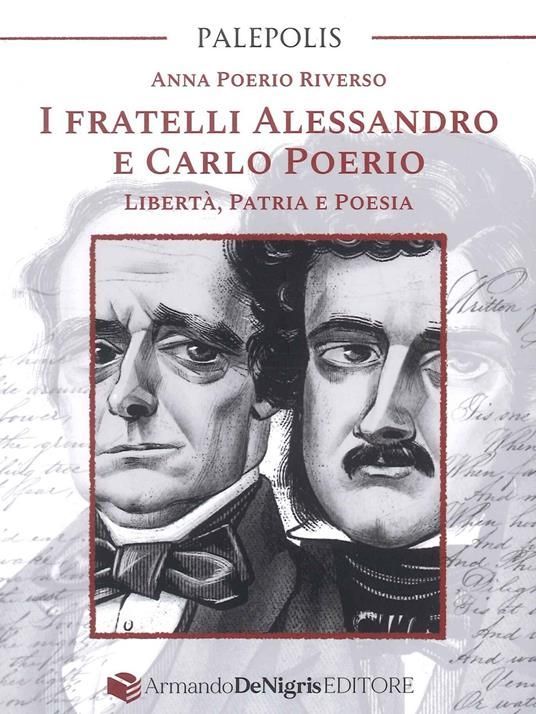"Life on Mars" - Salute mentale col Dr Vittorio Schiavone - "Le tre scimmiette"
Parliamo col Dott. Vittorio Schiavone, primario dell'Ermitage di Capodimonte (Na), di depressione agitata, stato misto, da non confondersi con la depressione ansionsa. Non riconoscere uno stato misto e trattarlo come depressione maggiore può cause enormi peggioramenti del paziente

“Dottore, sono venuta da lei perché mi hanno detto che ho una depressione farmacoresistente”.
"Cominciamo bene, pensai senza dire niente. Era già troppo sofferente e troppo spaventata per esordire con una delle mie solite battute; qui non c’era niente da sdrammatizzare, ma tante cose da chiarire".
Anna era una ragazza di 25 anni, che è stata male la prima volta all’inizio dell’università. Con la fretta che si addice a chi sta perdendo il treno, all’epoca le diagnosticarono un disturbo depressivo maggiore, perché era triste e svogliata. Era anche ansiosa, a dire il vero, ma le dissero che era normale visto che aveva da poco cominciato l’università. Tralasciando la diagnosi di depressione, trovo davvero singolare come si fosse così facilmente dato dell’ansiosa ad una ragazza che veniva descritta, sino a quel momento, come placida, serena, al limite del menefreghismo; ancor più singolare è che una cosa del genere, un sintomo che irrompe nella vita di una giovane donna così diverso dalla sua modalità di comportamento solita, così poco comprensibile per come è fatta, sia considerato ovvio, scontato, lapalissiano. Non potevo fare a meno di pensare che esistono ancora colleghi che non sanno ascoltare, e che non sanno ascoltare perché non sanno cosa ascoltare. Così, mentre lei mi parlava aiutata dalla sorella (la madre non l’aveva accompagnata perché ricoverata, era affetta da disturbo bipolare), facendo continuamente scricchiolare la sedia non riuscendo a stare ferma, io non potevo fare a meno di pensare che, oltre a non sapere ascoltare, talvolta i colleghi hanno anche perso la capacità di guardare; non me ne vogliate, non sono qui a criticare nessuno e tutti commettiamo errori, ma qui è proprio il metodo che manca. Il colloquio psichiatrico non è una distribuzione di diagnosi, ma l’atto più profondo di una disciplina clinica che deve interpretare il linguaggio, verbale e non verbale, della persona che abbiamo di fronte. Lo psichiatra è un interprete, un traduttore, e la traduzione deve impegnare tutti i sensi che ha. Il paziente ci dice sempre la sua diagnosi, anche se lui non la conosce; e, se è vero che non sempre la diagnosi è ciò che sembra, è vero anche che sembra sempre ciò che è. Lo psichiatra deve disattende il sintomo.
Intervallavo questi miei pensieri con pochissime domande, più sul passato che su questo presente che si stava consumando dinnanzi a me; no, il presente era chiaro, mentre il passato un’ipotesi ed il futuro, per sua fortuna, non invadente.
“Ascoltatemi, voi siete venute qui da me per curare una depressione farmacoresistente, ed io vi dico certamente che non lo è. Non è farmacoresistente perché questa non una depressione. La notizia buona è che Anna starà bene, ed anche in breve tempo; l’altra notizia, che per consuetudine dovrebbe essere cattiva ma che cattiva non è, in questo caso, è che questo episodio non finirà qui, ma ci costringerà a stare attenti per qualche mese, per vedere le cose come vanno. Nulla di brutto all’orizzonte, perché Anna starà bene, lo ribadisco, ma ci vuole tempo: non devo convincervi di una diagnosi, ma è la diagnosi che con il tempo, deve convincere me”.
In onestà, non avevo molti dubbi sulla diagnosi e sul decorso, ma non si può dire ad una ragazza che sta male da già troppi anni e che si stava convincendo che stava male perché aveva qualcosa di difficile da curare (finalmente qualcosa con un nome e cognome!), che adesso doveva cambiare idea, ed affidarsi ad un altro psichiatra anch’esso così carico di certezze da poterla convincere di avere la depressione degli unicorni. Non potevo fare a meno di pensare che esistono ancora colleghi che non sanno parlare, e saper parlare vuole anche dire sapere quando tacere. È superfluo dire che, benché pensassi che non si poteva salvare niente delle precedenti valutazioni (il beneficio del dubbio solo alla prima, perché un esordio può essere molto difficile da diagnosticare), la rassicurai che nessuno aveva sbagliato, che certe condizioni si rivelano con il tempo. Non lo feci solo per una ovvia deontologia, ma soprattutto perché sarebbe stato dannoso per Anna e sua sorella sapere che avevano perso tempo, che perseverando in certe scelte avevano contribuito a perpetuare questa sofferenza. Ma lo feci soprattutto perché parlare male di qualcun altro non mi rende un professionista migliore: io devo aiutare a risolvere un problema, non affermare di essere più bravo di qualcun altro.
“Quindi sono bipolare, come mamma?
"Questo ce la dirà il tempo: la diagnosi non è un atto di fede. Ti invito a riflettere su due cose. La prima è che, anche se non capissi nulla di psichiatria, dopo cinque diversi antidepressivi ed ansiolitici vari, penserei che ciò che hai non si può curare in questo modo, qualunque cosa sia. La seconda è che potresti anche avere una diagnosi simile a quella da mamma, ma essere bipolare a modo tuo: non gestire questo disturbo come fa lei, che decide ad esempio, da ciò che mi dici, di non prendere la terapia, ma assumerla con regolarità. Il vestito che sta male a lei può stare bene a te, non credi?”.
"In verità io assomiglio a papà, sono più slanciata".
Finalmente un accenno di sorriso.

Share
Tutti gli articoli