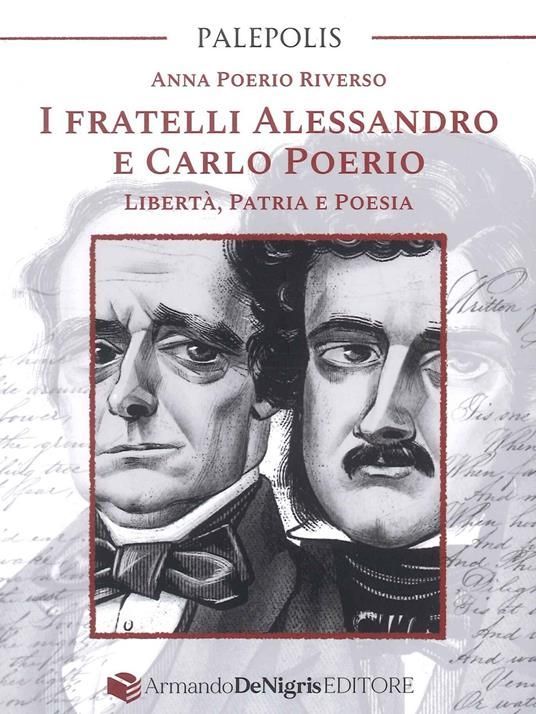Life on Mars? - a cura di Vittorio Schiavone - Non dire una parola che non sia…
Il complicato rapporto medico-paziente nella verve narrativa dello psichiatra Vittorio Schiavone, primario alla Clinica Hermitage di Capodimonte (Na)

“Perché non mi ha risposto, Dottore?”.
Generalmente questa domanda mi viene posta con un tono rivendicativo ed una espressione tra lo stupito e l’incazzato. Già, perché non l’ho fatto? Non l’ho fatto perché sono cattivo, o più propriamente perché sono uno di quegli psichiatri, o medici in generale, che non vuole sentire ragioni e vuole vedere i suoi pazienti soltanto a studio, quando pagano? O perché, magari, voglio punire quel determinato paziente per non essere venuto all’appuntamento senza neppure avvisarmi, o quell’altro perché fa sempre di testa sua, sospende la terapia e vuole che io faccia miracoli istantanei? Già, perché mai non ho risposto? Per rispondere a questa domanda, credo sia opportuno smarcarsi da un grosso equivoco.
Fughiamo ogni dubbio: per quanto particolare, la psichiatria è una disciplina professionistica medica. Ha di certo una natura singolare, molto diversa dalle altre branche della medicina ma non perché sia una missione: del resto, nessuna altra attività professionistica lo è. Ha una natura particolare perché il rapporto psichiatra-paziente è un rapporto incredibilmente stretto in quanto è un legame che si fonda sulla parola. Le parole, lontane dall’essere dei significanti fatti di segnetti insettiformi, sono la traduzione, in voce e su carta, della nostra anima; certo, l’anima risiede nel cervello e non nel cuore, muscolo fondamentale ma piuttosto rozzo ed inelegante, ma questa è un’altra storia con la quale, di certo, non si può fare una poesia o una canzone.
Fermiamoci all’anima, dunque: lo psichiatra ed il paziente, in qualche modo, portano a contatto le loro anime. Il paziente lo fa in una maniera nave, ed è giusto che sia così, mentre lo psichiatra lo fa perché è il suo mestiere. In una maniera codificata, ragionata, scientifica a suo modo, condita con un po’ di esperienza che galleggia nel mare di tutti i libri che ha letto, una distesa sconfinata d’acqua in cui galleggiano arcipelaghi di pazienti. Tutti fissati nella sua memoria, tutti lì. Il tutto con un solo, dichiarato scopo: compiere atti terapeutici. “Non dire una parola che non sia terapeutica”, direi parafrasando i CCCP. “Dottore, dì una cosa terapeutica”. Temo che questa storia delle citazioni mi stia sfuggendo di mano.
È difficile dire una singola cosa che sia terapeutica in terapia, perché tutto in terapia deve essere terapeutico. Un atto terapeutico è un atto che prescinde dal terapeuta stesso e che è compiuto nel solo interesse del paziente. Può essere una stretta di mano o un vaffanculo, poco conta: è la qualità dell’atto che lo caratterizza.
È terapeutico per un terapeuta non avere confini? Domanda retorica. Quali sono, allora, i confini? Non rispondere al telefono, tra un controllo e l’altro? Concedere una telefonata tra una seduta e la successiva? Rispondere di notte, ma solo se è un’emergenza? E chi stabilisce se è davvero un’emergenza oppure no? Lo psichiatra, magari fornendo una check-list? Il paziente, vale a dire la regia costituita dal comitato attacchi di panico? I familiari? E quanti “aiuti dallo psichiatra” è possibile giocarsi per ogni partita? Per non sembrare più stronzo o cattivo di quanto già non voglia mostrare, credo sia giusto contestualizzare un po’, ora che lo scenario lo abbiamo capito.
I confini credo sia giusto li stabilisca lo psichiatra. Ci sono dei confini generali, vale a dire dare una disponibilità oraria per rispondere alla telefonate ed un canale (io preferisco la mail, perché ho disinstallato anni fa Whatsapp per legittima difesa) da utilizzare per comunicazioni in altre fasce orarie. Non messaggi privati sui social, non agguati sotto studio, non messaggi nelle bottiglie, non ninja appostati sotto casa. A cosa serve questo limite? A far comprendere ciò che è importante e ciò che non lo è davvero, a insegnare a distinguere un’emergenza da una intolleranza ad una minima frustrazione. Non sarebbe terapeutico rispondere ad una telefonata a ferragosto, domenica, alle 22 30 che chiede di fissare un appuntamento urgente al ritorno dalle vacanze (“Torna tra 10 giorni Deve aspettare così tanto? Ma lui sta male!”) ossequiando il sintomo del paziente stesso.
Ecco, quella frustrazione è necessaria. Diversamente, venerdì scorso, mentre ero ancora in ferie, sono rimasto mezz’ora al telefono con una paziente che aveva risentito della seppur breve pausa estiva dalla terapia; ho preferito così piuttosto che anticiparle la seduta, cosa che pure avrei potuto fare, spiegandole di quanto importante fosse imparare a tollerare quella frustrazione. Ecco, due situazioni simili che richiedono due atti terapeutici diversi. E poi, credo sia giusto che anche lo psichiatra si ridimensioni: non è dio, le emergenze autentiche non può risolverle con una telefonata.
“Perché la sua domanda poteva aspettare”.
“Ma se non sa nemmeno cosa volevo chiederle!”.
“Crede davvero che io non lo sappia?”. Chiusi così ad effetto, mi aspettavano per un miracolo dopo venti minuti, o poco più.
Share
Tutti gli articoli